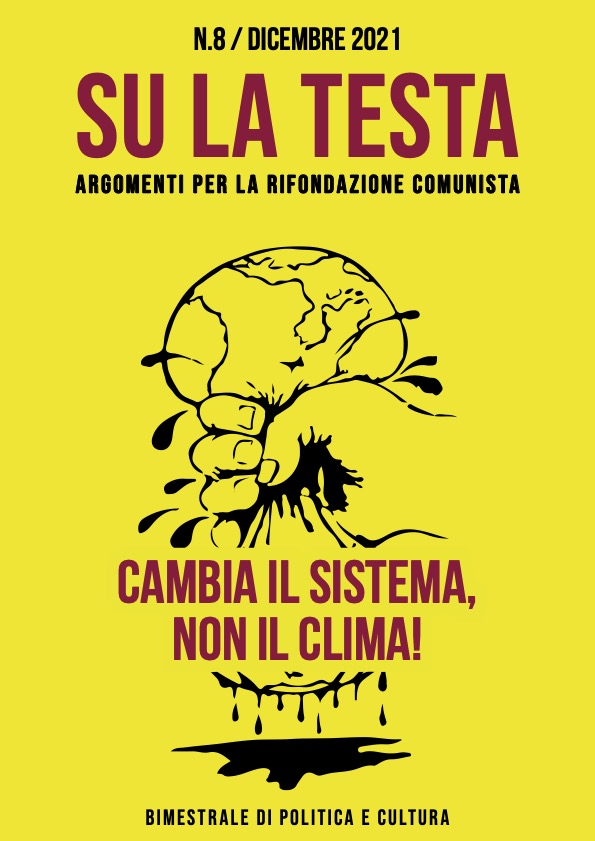ANDIAMO A FONDO
APPROFONDIMENTI SU TEMI D’ATTUALITA’
Contributo di Monica Quirico sul 25 Aprile.
Resistenza, Anpi e intellettuali (minuscoli), dieci spunti di riflessione:
Nemico pubblico numero uno – Maiuscole e minuscole – Solidarietà a senso unico – Quale Resistenza? – Strategie complementari di manipolazione della storia – La resa degli intellettuali – Acribia filologica a corrente alternata – Il capro espiatorio – L’Anpi, la Costituzione e la democrazia – La Resistenza come promessa
Pubblicato da franco.cilenti in Lavoro e salute
I. Nemico pubblico numero uno. Il linciaggio, personale oltre che politico, cui è sottoposto da settimane il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, ha pochi precedenti nella storia repubblicana; che a compierlo siano per lo più giornalisti, intellettuali e politici “progressisti” (alcuni con trascorsi rivoluzionari), a cui la destra ben volentieri delega il lavoro sporco, rende la vicenda paradigmatica dell’imbarbarimento del sistema mediatico e dell’irreversibile declino di un intero ceto intellettuale.
II. Maiuscole e minuscole. La nostra Resistenza (ma anche quella francese, norvegese, jugoslava…) si fregia dell’iniziale maiuscola perché costituisce uno specifico fenomeno storico (la guerra partigiana contro l’occupazione nazifascista); allo stesso modo, si scrive Rinascimento per distinguere, nella storia della cultura, una determinata epoca da usi generici, talvolta impropri, del termine – come ad esempio il luminoso avvenire che Renzi preconizza per l’Arabia Saudita. Che le altre resistenze, a partire da quella ucraina, si scrivano con la minuscola non comporta una loro deminutio capitis, ma semplicemente il riconoscimento di diverse condizioni storiche.
III. Solidarietà a senso unico. Giornalisti e intellettuali con l’elmetto (indossato sulla poltrona) vedono nell’invio di armi all’Ucraina un discrimine morale: la solidarietà (dei veri democratici) contro l’inerzia (delle anime belle). Vano sarebbe cercare, nei loro interventi passati, tracce di un appoggio altrettanto incondizionato ad altre resistenze, che pure ci sono state, negli ultimi decenni: quella irachena (non riducibile ai sostenitori di Saddam Hussein), quella afghana (non identificabile coi soli talebani), per tacere di quella curda (scomoda, con il suo confederalismo democratico) e, ça va sans dire, quella palestinese. Tutti popoli che hanno subito l’aggressione di uno o più paesi stranieri (dagli Stati Uniti alla Turchia) e che però, anche quando non sono mancate espressioni di condanna dell’occupante, non sono stati considerati meritevoli, da parte del “Corriere” o di “Repubblica” o di “Micromega”, di un sostegno armato da parte dell’Occidente e dell’Italia. Forse perché gli aggressori erano gli Stati Uniti o qualche loro irrinunciabile (per quanto impresentabile) alleato. E meno che mai si è rispolverata la nostra Resistenza. Quanto ai civili siriani bombardati implacabilmente dalla Russia, hanno agonizzato nell’indifferenza generale. Certo non hanno chiesto di inviare armi a movimenti per cui pure simpatizzano (come quello curdo o palestinese) l’Anpi o altre organizzazioni pacifiste, ritenendo che in qualsiasi caso rispondere alla guerra con più guerra conduca solo alla catastrofe, come ha ben visto Emergency in questi anni. Piuttosto, hanno insistito per una soluzione diplomatica dei conflitti. Inascoltati, come oggi. Chi è di parte, dunque? Chi è “passivo”?
IV. Quale Resistenza? Polemizzando con Luigi Salvatorelli, che equiparava la lotta partigiana a quella dei caduti del Grappa e del Piave, Franco Antonicelli, fulgido intellettuale che per fare il suo dovere aveva assunto la presidenza del CLN Piemonte, puntualizzava: “Il definire meglio le due «resistenze» non significa opporle fra loro per farne risultare vincitrice una: significa fare una più perspicua opera di storia e trarne le naturali conseguenze. Nasce il sospetto che nell’equiparazione si voglia a bella posta togliere i caratteri distintivi, annullarli in una superiore ma arbitraria identità”. In alcuni paesi, tra cui il nostro, la Resistenza fu, certo, una lotta di liberazione nazionale (dall’invasore nazista), ma anche una guerra civile (contro il fascismo come regime e contro i fascisti che quel regime incarnavano) e, per una parte del movimento partigiano, una guerra di classe (contro il padronato agricolo e industriale, che aveva appoggiato Mussolini come “soluzione” della crisi sociale). Quest’ultima dimensione costituisce uno dei maggiori rimossi della nostra storia, non secondariamente per la scelta del PCI di oscurarla, con la svolta di Salerno, per accreditarsi come partito dell’unità nazionale. Della Resistenza invocata oggi come “patentino” della legittimità della resistenza ucraina si recupera ovviamente solo la componente di liberazione nazionale nella sua dimensione armata, con buona pace del contributo della resistenza non violenta.
V. Strategie complementari di manipolazione della storia. La memoria pubblica funziona ormai come Amazon: chiunque può cliccare sull’articolo (il personaggio o il fenomeno) che più gli conviene in quel momento, senza curarsi né della filiera, né della destinazione e dell’impatto. La strumentalizzazione della storia, una piaga non solo italiana, si presenta sotto due volti. Il più rozzo, che nel nostro paese produce effetti particolarmente mefitici, è quello dell’appiattimento di processi ed eventi sul paradigma vittimario: nell’indistinzione dei morti, si compie l’assoluzione dei vivi (i fascisti e gli esponenti del potere istituzionale ed economico), mentre il giudizio della Storia condanna all’infamia i “rossi”. Il volto più raffinato, per così dire, consiste nell’appropriazione di personaggi e processi “eccentrici”, non prima di averli depurati delle loro componenti disturbanti: così il socialdemocratico Olof Palme, odiato dalla destra in vita, da morto viene canonizzato, ma in quanto campione del liberalismo; analogamente, Antonio Gramsci diventa icona di italianità, ma per la sua indiscutibile (?) ispirazione liberale. Nel caso della Resistenza, si è passati con la massima disinvoltura dalla criminalizzazione degli ultimi decenni a una repentina (e verosimilmente assai transitoria) beatificazione. L’arroganza intellettuale e morale della classe dirigente ha passato ogni limite.
VI. La resa degli intellettuali. Scomparse le organizzazioni di massa (se non quelle di destra) che assicuravano loro un ruolo sociale, gli intellettuali “progressisti” (il maschile è intenzionale) si sono adeguati alle modalità comunicative di un sistema mediatico ibrido, in cui la logica binaria dei social avvelena anche i media tradizionali; non vi è posto per l’argomentare razionale e il confronto civile tanto cari ai liberaldemocratici, ma solo per la rissa. Ecco allora che, anziché contribuire al dibattito pubblico mettendo a fuoco le aporie del diritto internazionale (dalle ambiguità del principio di autodeterminazione dei popoli all’impotenza dell’Onu di fronte al militarismo), i nostri intellettuali democratici hanno sfoderato, in occasione dell’aggressione russa all’Ucraina, una logica binaria amico-nemico, alleato-traditore, degna delle peggiori fasi della Guerra fredda e per giunta incattivita da una comunicazione urlata e diretta alla delegittimazione dell’interlocutore. Pochi vi si sono sottratti; tra loro, Michele Serra, che, pur dichiarandosi a favore dell’invio di armi all’Ucraina, si è rifiutato di partecipare al derby fra le opposte tifoserie, confessando anzi il suo tormento interiore. Ma, appunto, si tratta di casi isolati. Lo “stile” del dibattito è stato dettato piuttosto da chi, come Paolo Flores d’Arcais, ha definito “oscena” la posizione di Pagliarulo, salvo poi invitarlo a un confronto pubblico (prima ti demolisco, poi parliamo, insomma).
VII. Acribia filologica a corrente alternata. Mediocri pennivendoli con l’elmetto si sono presi la briga (sottraendo tempo a cause più nobili) di andare a spulciare i post sul Donbass scritti da Pagliarulo a partire dal 2014, per dimostrarne in modo inequivocabile il “putinismo”. Dunque, commenti di sette-otto anni fa, su cui si può essere più o meno in accordo, sono usati per squalificare le dichiarazioni di oggi, e con esse la persona tout-court; un procedimento metodologicamente assai discutibile, considerando che Pagliarulo, e l’Anpi, hanno immediatamente e ripetutamente condannato l’aggressione russa. Ancora più strumentale appare poi una pubblicazione dei post di Pagliarulo completamente avulsa dalle contemporanee prese di posizione di organismi transnazionali al di sopra di ogni sospetto, che constatavano nella regione contesa gravi violazioni dei diritti umani da entrambe le parti: i nazionalisti filorussi come l’esercito e le formazioni paramilitari ucraine (si veda, tra gli altri, il rapporto del 2017 dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/UA/UAReport19th_EN.pdf). La stessa sorte è toccata del resto al comunicato di Pagliarulo sul massacro di Bucha. Il presidente dell’ANPI ha chiesto una commissione d’inchiesta indipendente per accertare le effettive responsabilità: esattamente quello che ha sollecitato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per la semplice ragione che è ciò che prevede il diritto internazionale. Ma questo particolare deve essere sembrato ininfluente, ai guerrafondai nostrani, che lo hanno per lo più taciuto.
VIII. Il capro espiatorio. Per gli avversari dell’Anpi e del movimento pacifista, Pagliarulo rappresenta un bersaglio perfetto: ha un passato comunista (una colpa da cui non ci si redime, in Italia, se non rincorrendo la destra fino ad autoliquidarsi) e non può contare sull’appoggio di organizzazioni di massa. Il PD, che di massa non è più, si pone anzi come uno dei suoi più accaniti detrattori. Attribuendo a Pagliarulo posizioni “vergognose”, si vende all’opinione pubblica una narrazione rovesciata, in cui a essere faziosi (perché “putiniani”) e inerti (perché complici) sono i pacifisti. In questo modo, si devia l’attenzione da chi è davvero compromesso con Putin così come da chi si preoccupa soltanto di vendere armi, non di perseguire la pace per via negoziale. Così, mentre i sinceri democratici chiedono le dimissioni di Pagliarulo, Salvini, i cui rapporti con Mosca sono noti a tutt@, se l’è cavata con la passeggera umiliazione patita in Polonia. Anche in questo caso sono stati rispolverati vecchi post, che hanno, sì, dato adito a sarcasmo, ma non alla richiesta di dimissioni della Lega dal governo. Mentre Pagliarulo viene additato al pubblico ludibrio come traditore della patria e della democrazia, chi sacrifica i diritti sociali delle classi popolari, imponendo, dopo due anni di pandemia, l’aumento delle spese militari e le ricadute energetiche di una guerra che in alcun modo tenta di arrestare, riceve il plauso di un apparato mediatico nelle mani di un oligopolio (i cui azionisti controllano anche buona parte dell’industria bellica: si pensi a Gedi/Exor). Infine, mentre si infierisce su Pagliarulo, nessuno chiede lo scioglimento di Forza Nuova, che ha legami ideologici nonché militari con la Russia di Putin.
IX. L’Anpi, la Costituzione e la democrazia. Perché l’Anpi oggi è ancora, anzi, più che mai, necessaria? Dovrebbe bastare un semplice dato, per chiudere la questione: l’Associazione dei partigiani conta 120.000 iscritti; Fratelli d’Italia 130.000. In un paese in cui, stando ai sondaggi, il 40% dell’elettorato voterebbe per due partiti di estrema destra, l’Anpi, con tutti i limiti che può avere, è uno dei pochi presidi di democrazia rimasti. Ed è proprio per questo che la si vorrebbe liquidare, con argomenti pretestuosi, come la sua obsolescenza (come se non si fosse rinnovata, nelle finalità e nel corpo militante, già da diversi anni) o la sua “faziosità”: celebri pure il 25 aprile, ma non si impicci di politica (una logica introiettata, purtroppo, anche da non pochi dei suoi iscritti). Delegittimando l’Anpi, si vuole archiviare definitivamente l’antifascismo come DNA della cultura politica nazionale e, con esso, quella Costituzione che, nata dalla Resistenza, ne raccoglie la triplice eredità di lotta di liberazione, guerra antifascista e lotta di classe: un circolo virtuoso che risulta intollerabile, nell’epoca di irreggimentazione permanente che sempre più ci imprigiona.
X. La Resistenza come promessa. “Come non illudersi che il nuovo Stato italiano avrebbe preso atto di tutto quello che la lotta partigiana significava: la forza di un popolo quando gli comanda la coscienza morale; l’intuito giusto della salvezza e libertà nazionali; la distruzione dei vecchi sistemi statali a base militaristica; la possibilità di un’esperienza di autogoverno? Come non ritenere inevitabile che la Resistenza, che oggi osava affrontare armata il fascismo e lo sconfiggeva, avrebbe distrutto tutto quanto il fascismo aveva rappresentato nella storia italiana e non soltanto italiana: la boria nazionalistica, lo spirito di divisione dell’Europa e del mondo intero, l’ossessione imperialistica, il bruto attivismo, lo stato etico, il capitalismo cieco? La «liberazione» doveva diventare «tutta la libertà»”. In queste parole, pronunciate da Antonicelli nel 1949, sono scolpiti i fondamenti dell’antifascismo italiano, quello rinnovatore, nato ben prima dell’8 settembre 1943 e non esauritosi con il 25 aprile 1945; a noi, fuori e dentro l’Anpi, il compito di inverare la promessa di redenzione dal nazionalismo, dal militarismo e dall’ingiustizia che esso ha dischiuso.
Monica Quirico
Storica
25/4/2022
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
L’aggressione sferrata all’Ucraina si accompagna alla distruzione, in Russia, di tutte le esperienze di autorganizzazione sociale: si punta a “risolvere” la crisi interna con la guerra. Spunti di Monica Quirico da una videoconferenza sulla Russia di Putin.
L’aggressore dall’interno
di Monica Quirico
Il Movimento socialista russo, nato nel 2011 dalla fusione di diversi gruppi comunisti, socialisti e anticapitalisti, ha organizzato, il 27 marzo, una videoconferenza in inglese, dal titolo L’aggressore dall’interno (Inside the aggressor), cui hanno partecipato alcuni studiosi e giornalisti russi (con l’eccezione di una sociologa francese). L’idea alla base dell’iniziativa era quella di condividere con un pubblico internazionale riflessioni dall’interno, appunto, sulla situazione in Russia, per capire come si è arrivati all’invasione dell’Ucraina, interpretata come risultante dell’involuzione del regime di Putin e insieme come viatico a una sua ulteriore torsione autoritaria, se non peggio.
Il pregio della conferenza è stato quello di abbinare una ferma condanna della guerra in corso ad un’analisi di classe della società russa, rifuggendo così da quelle semplificazioni (diffuse anche a sinistra) che evocano “la Russia” come se fosse un’entità astratta. Di seguito riporto quelli che dal mio punto di vista sono stati gli spunti più interessanti della discussione, lasciando per ultimo l’intervento più stimolante.
Maxim Alyukov, studioso della comunicazione politica, ha presentato i risultati delle sue ricerche sulla propaganda del Cremlino, mettendo in luce come essa penetri facilmente in quella parte di società che, avendo subito un processo di de-mobilitazione (tipico dei regimi autoritari), si aggrappa agli schemi interpretativi confezionati dal regime per dare un senso a un mondo complesso e in perenne trasformazione. Un sistema mediatico ibrido (ossia comprendente sia i media tradizionali sia i social) viene utilizzato – anche attraverso la manipolazione dei motori di ricerca – per veicolare una narrazione che ispira fiducia non perché “vera”, ma perché coerente. In questa propaganda non vi è alcun riferimento a valori o slogan della sinistra; chi in Russia condanna la guerra viene zittito con la domanda: “dove eravate negli ultimi otto anni, quando il Donbass veniva bombardato? Perché parlate solo ora?”. L’effetto della propaganda tuttavia è ambivalente, perché se da un lato alimenta il conformismo, dall’altro, rivelando la manipolazione cui sono soggetti i media, può suscitare sfiducia nell’esistenza stessa dell’obiettività.
Su questo processo si sofferma, da una prospettiva diversa, anche Polina Aronson, giornalista e sociologa delle emozioni, che ha innanzitutto confessato il senso di spaesamento suo e di moltƏ studiosƏ: l’invasione dell’Ucraina lƏ ha coltƏ del tutto impreparatƏ; è perfino difficile, ammette, formulare delle domande che permettano di far luce sulla reazione della gente comune. Aronson osserva come in Russia anche la psicologia abbia contribuito alla depoliticizzazione, solleticando un individualismo esasperato e insistendo sulla neutralità come stato psichico più sano di fronte a un mondo complesso; una posizione che oggi si traduce nell’equidistanza tra aggredito e aggressore. È stata così forgiata una particolare soggettività che rifiuta l’idea dell’interdipendenza degli esseri umani e non è in grado di resistere alle pressioni esterne; una soggettività che si riverbera anche in un linguaggio parimenti depoliticizzato e tutto rivolto all’interno. È importante tenere a mente che la soggettività di cui si parla non è sinonimo di soggetto autonomo, bensì di individuo isolato e succube di processi politici calati dall’alto. Naturalmente, sottolinea Aronson, a immedesimarsi con una soggettività di questo tipo è la borghesia urbana, i ceti colti, molto meno lavoratori e lavoratrici che guadagnano poco e vivono in aree periferiche.
Sulle divisioni di classe riflette anche Karine Clément, studiosa francese che ha vissuto a lungo in Russia finché, nel 2019, non ne è stata bandita. A sua volta disorientata dagli eventi, descrive una società russa in cui, prima della sua partenza forzata, germogliavano forme di mobilitazione dal basso, che davano vita a una politica pragmatica perché orientata ai bisogni delle comunità locali e si sottraevano, con le loro modalità autorganizzate, alla politica moscocentrica e dipendente in tutto e per tutto da Putin. Non era estraneo a questo risveglio un sentimento di orgoglio nazionale non necessariamente sinonimo di nazionalismo, bensì da intendersi come appartenenza a una comunità. In queste esperienza fioriva anche la critica alle politiche sociali di Putin da parte della classe operaia (in senso lato), sia pure espressa in contesti informali o comunque molto circoscritti. Tre sono i gruppi in cui Clément suddivide la società russa: 1) i conformisti, ossia i fautori di un nazionalismo di stato, da amplificare tramite la propaganda; 2) gli elitisti morali o intellettuali, che si sentono superiori alla massa ignorante (tra loro figurano sia sostenitori che oppositori di Putin); 3) il gruppo più interessante, appunto lavoratori e lavoratrici, che nella nazione russa vedono, sì, un valore, ma non primario rispetto a quella che è la loro esperienza di vita, interpretabile piuttosto secondo categorie di classe – diseguaglianza e sfruttamento, ricondotte a quell’oligarchia di cui Putin è capo. Di fronte al regime, era acuto già prima della guerra un sentimento di impotenza, che ora – avverte Clément – è inevitabilmente aumentato e rischia di sgretolare quel senso di “abitare questo mondo” faticosamente conquistato attraverso le pratiche dal basso e di conseguenza accrescere la sfiducia verso concetti astratti come la democrazia.
Anche nell’intervento di Kirill Medvedev, giornalista e attivista, risuona il tema della depoliticizzazione e demobilitazione, processi finalizzati a produrre un individualismo esasperato e intensificati dalla guerra, che aggrava ulteriormente (con l’inasprirsi della repressione) una situazione già molto problematica dal punto di vista politico e sociale. La lotta contro la vocazione imperialistica della Russia (in certa misura incorporata anche dall’URSS) e insieme contro il neoliberalismo – Putin infatti è espressione di entrambe le tradizioni – richiede la costruzione di una rete transnazionale che unisca la sinistra anticapitalistica russa e quella occidentale. Occorre costruire un nuovo sistema di sicurezza internazionale, ridimensionando i blocchi militari, nella consapevolezza tuttavia che l’imperialismo russo è al momento il più pericoloso. La mobilitazione nei paesi occidentali contro la guerra è importante, come strumento di pressione sul regime, e non solo per fermare l’aggressione, ma anche per cambiare il corso della politica interna: se Putin distrugge l’Ucraina, allora annienta anche la società russa.
L’esortazione di Medvedev – è la Russia che va denazificata! – si lega all’analisi dello storico Ilya Budraitskis, che fornisce elementi preziosi per valutare il rischio di fascistizzazione del paese, un tema molto dibattuto nella sinistra russa come in quella occidentale. Con la guerra, constata Budraitskis, la Russia di Putin ha imboccato una nuova fase storica, contrassegnata da una rapida evoluzione dall’autoritarismo al totalitarismo. Viene meno, infatti, anche lo spazio limitato che prima sussisteva per il dissenso; l’unica libertà di espressione concessa è quella a favore del regime; ogni forma di autorganizzazione (anche quelle dei movimenti ultranazionalisti!) ora è bandita; il pericolo esterno viene sfruttato per rivendicare una totale unità tra leader e popolo.
Alla luce di questi mutamenti, è lecito parlare di fascismo? Budraitskis parte da quelli che sono considerati i tratti distintivi del fenomeno nella sua forma classica: l’ideologia (eclettica, priva di coerenza) e un movimento di massa; l’una e l’altra impiegati in funzione antirivoluzionaria, in uno scenario in cui la borghesia non è in grado di risolvere per altre vie la crisi. Tuttavia lo storico russo ricorda anche interpretazioni del fascismo come quella di Karl Polanyi, in cui decisivo è non il movimento (di massa), bensì la mossa (dall’alto); in tale prospettiva, si guarda al fascismo come risultante di una strategia promossa dalla classe dirigente. In continuità con tale linea interpretativa si pone la categoria di post-fascismo proposta da Enzo Traverso, che Budraitskis ritiene essere molto calzante al regime di Putin; esso ha rappresentato infatti una svolta di segno totalmente antirivoluzionario, tant’è che una componente fondamentale della retorica putiniana è la criminalizzazione di qualsivoglia rivoluzione. A tale proposito, è stata molto significativa la rottura definitiva con Lenin, e con tutta l’eredità bolscevica, operata da Putin nel discorso in cui ha annunciato l’inizio dell’”operazione militare speciale”. Mentre qualche anno fa il leader russo individuava nel crollo dell’Urss una catastrofe, ora la lettura viene ribaltata: non la fine, ma la creazione dell’Urss ha rappresentato una calamità, non ultimo perché ha sancito il principio di autodeterminazione delle diverse repubbliche.
L’aggressione sferrata all’Ucraina si accompagna alla distruzione, in Russia, di tutte le esperienze di autorganizzazione sociale: si punta a “risolvere” la crisi interna con la guerra; una guerra che, per giunta, si prolunga (la blitzkrieg è fallita) e non può essere vinta (anche per l’effetto delle sanzioni occidentali), diventando così un elemento permanente della politica interna.
Ciò che secondo lo studioso contraddistingue la trasformazione fascista della Russia è il suo porsi non come inizio di qualcosa di nuovo, bensì come fine, drammatica ma logica, del regime costruito prima da Eltsin e poi da Putin, caratterizzato dalla conversione dell’economia, della cultura e dell’antropologia al mercato. Fascistizzazione come agonia, insomma. Un capolinea reso possibile dal trionfo dell’individualismo neoliberale e dalla demolizione di ogni forma di autorganizzazione sociale; un quadro che rende poco realistica la speranza di un’opposizione di massa in grado di rovesciare il regime di Putin.
Per chiudere con una nota positiva: Polina Aronson, che vive a Berlino, è rimasta molto colpita dalla mobilitazione della capitale tedesca per accogliere i profughi ucraini (non nascondendosi peraltro che ad altre crisi umanitarie non si è risposto con la stessa generosità…). Si augura che questa “produzione collettiva di supporto” da parte sia dello Stato sia dell’autorganizzazione sociale rimanga come patrimonio da cui partire, per costruire comunità solidali. Costruire le condizioni perché questa speranza diventi realtà è uno dei compiti della sinistra anticapitalista europea.
Monica Quirico
Storica
30/3/2022 https://transform-italia.it