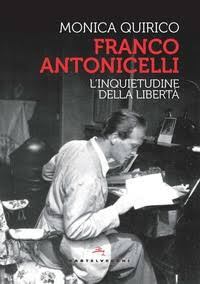GETTING BACK TO THE BEATLES
NOW AND THEN: E POI….
ASCOLTARE E VEDERE I BEATLES FUORI DAL TEMPO LASCIA UNO STRANO, AMBIGUO RETROGUSTO.
Forse è meglio getting back to Get Back….
La storia di un brano che ha fatto epoca: Get Back
PRIMA PARTE
Il documentario sui Beatles di Peter Jackson aiuta a riconoscere le origini proletarie e multirazziali della Liverpool della beat culture: tracce di una genealogia rimossa
«Non è il passato a dominarci, ma soltanto le sue immagini»
G. Steiner, Epigrafe di Le tombeau d’Alexandre, film di Chris Marker
Il recente e bellissimo docu-film di Peter Jackson (regista de Il Signore degli anelli, ma anche documentarista) sui Beatles ha riportato ancora una volta l’attenzione sul gruppo più parlato della storia del Rock. Ogni volta che la monumentalizzazione della beatlemania raggiunge un nuovo significato storico e sembra chiudere ogni «letteratura» lasciando spazio solo a ciò che Barthes chiamava «chiacchiera» – ogni volta che la «phony beatlemania has bitten the dust», si potrebbe dire con i Clash di London Calling (1979) – arriva qualcosa di inatteso sfidandoci a rigirare le pieghe di buona parte di quanto si è detto. La storia è sempre storia del presente, o meglio è sempre il presente che si fa (e proietta, scava) la sua (di) storia. Nulla riposerà mai in pace, gli aspiranti controllori della memoria sanno nell’intimo che non dormiranno mai sonni tranquilli. La cultura è sempre in movimento, è sempre lotta, e la lotta apre sempre nuove interrogazioni e connessioni, nuovi (retro)sguardi, rammentandoci proprio la (nostra) storicità. Miseria della storia, fortuna della memoria, sempre libera e soggettiva, reale e (in)attuale.
The Beatles: Get Back, dunque. Il prodotto si propone come un documentario del documentario Let It Be, girato da Michael Lindsay-Hogg (1940-) nel 1969 durante la preparazione dell’ultimo album dei Beatles su loro richiesta. La storia è nota, quello che venne commercializzato come un documentario doveva essere nelle intenzioni una specie di show televisivo attraverso cui presentare il loro successivo LP. Lindsay-Hogg, regista americano soprattutto di serie TV, noto anche per aver girato diversi film-concerti come The Concert in Central Park di Simon and Garfunkel (1982) e Neil Young in Berlin (1983), aveva già lavorato con i Beatles, oltre ad averli ospitati nella trasmissione BBC Ready Steady Go. I Beatles lo avevano ingaggiato in precedenza per girare dei brevi filmati (oggi videoclip) per il lancio di pezzi come Paperback writer, Hey Jude e Revolution. Il filmato di Lindsay-Hogg venne però accantonato per un periodo, a causa dell’esplicita acredine emersa nel quartetto durante il lavoro. I Beatles decisero comunque di farlo uscire nel 1970 come documentario, ma in una versione super-ridotta (di soli 80 minuti) come parte del lancio di Let it Be. Il filmato, dopo la diffusione delle famose immagini del concerto sul terrazzo della Apple tornò nell’oscurità degli archivi.
Il docufilm di Jackson, una mini-serie televisiva di più di sei ore di durata che riprende buona parte del materiale originale rimasta inedita, propone però un titolo diverso, semanticamente imparentato con l’originale, nel senso che vi si può stabilire un legame tra i due al di fuori del fatto che si tratta comunque di due pezzi famosi dei Beatles. È questa libera associazione di senso che propongo qui come punto di partenza, esterna in qualche modo a ciò che denotano in concreto le due espressioni; un’associazione generata dalla storicità come «sintesi disgiuntiva», per dirlo attraverso un concetto di Deleuze e Guattari. Get Back, dunque, notissimo brano dei Beatles, certo, e leitmotiv musicale-narrativo anche del docu-film di Jackson. Un primo discorso sul titolo si potrebbe infatti chiudere qui. E tuttavia vogliamo raccogliere la sfida semantica di un suo secondo intrinseco significato. Non tanto The Beatles: Get Back, ma getting back to the Beatles.
E com’era logico si è tornati. Tanto è già stato scritto anche su questo documentario, e tuttavia può essere utile tornare su alcuni dei suoi aspetti più interessanti, ma passati inosservati nella maggior parte dei commenti, soprattutto locali. Tornare su questi aspetti potrebbe consentirci di vedere cose – soglie, connessioni, storie – che non sempre vediamo quando abbiamo a che fare con «Miti di oggi», per tornare a Barthes. Si tratta di aspetti che potrebbero contribuire a mettere a fuoco in modo diverso non solo il fenomeno dei Beatles in sé, ma anche storie e processi – sociali, politici, culturali – a esso imbricati certo, ma il cui significato, così come la lotta semiotica per la sua appropriazione-connotazione (di nuovo Barthes), finisce qui per trascendere lo stesso oggetto in contesa.
Se si scorrono in rassegna la maggior parte dei commenti vedremo un ripetersi senza differenza dello stesso tipo di narrazione: un approccio alla storia dell’arte e della cultura (pop e non pop) non solo storico-biografico, si potrebbe dire «archeologico», e non certo nel senso che Foucault diede a questo particolare sintagma, ma soprattutto del tutto color-race-blind. È questo il dato da estrarre. Anche se nulla è fuori dalla cultura, da noi gli studi culturali restano poco frequentati come pratica di «close-reading» dei fenomeni sociali. Prevale un approccio alla cultura di tipo «oggettuale», «sacrale» e «museografico», anziché «prosaico» e «processuale». Inoltre, non vi è dubbio che nei nostri contesti la maggior parte delle «comunità interpretative», per riprendere qui il concetto di Edward Said, continuano a operare all’interno di un discorso caratterizzato da una sorta di naturalizzazione della bianchezza. Si tratta di un atteggiamento oramai del tutto anacronistico, di un residuale rovescio del privilegio bianco, soprattutto se si guarda le lotte politiche e culturali che stanno investendo sempre di più i nostri spazi e territori.

La vera storia di un brano che ha fatto epoca
SECONDA PARTE
«No Pakistanis»: Get Back to where you once belong
Entriamo dunque nel documentario fissando l’attenzione sul brano che dà il nome (e il senso forse) all’operazione: Get Back. Una delle cose interessanti che apprendiamo mentre guardiamo il suo «processo lavorativo» – rubando la nota espressione di Marx – è che si tratta di un brano nato come sentimento/manifestazione di protesta nei confronti dei movimenti anti-immigrazione dell’epoca. Siamo nel 1969, sarà un periodo spartiacque in Gran Bretagna rispetto alla questione razziale-migratoria, ovvero anni di riots, violenze e omicidi apertamente razzisti. È necessario ribadirlo: questione razziale-migratoria e non semplicemente «migratoria»: sono due espressioni (o concetti) che non rendono visibile lo stesso fenomeno, non parlano della stessa cosa. Chiamarla soltanto migratoria sarebbe forse più in sintonia con l’occhio prevalente dalle nostre parti, infatti è così che se ne parla spesso. Ma oramai, dato tutto ciò che le lotte antirazziste delle popolazioni nere hanno reso visibile, e cioè la centralità del colonialismo e del razzismo nella costituzione materiale e culturale del «capitalismo razziale» moderno (vedi C. Robinson, Black Marxism), non potrebbe non apparire come un gesto mistificatorio, come il sintomo di uno di quei trabocchetti inconsci tipici della storica «innocenza bianca» occidentale.
Se contestualizziamo il pezzo, e le intenzioni iniziali di McCartney, vediamo tutto questo in modo molto più chiaro. Nel 1968 vi era stato il famoso «Rivers of Blood Speech» di Enoch Powell, una sorta di requisitoria pubblico-politica incentrata sulla richiesta di uno stop all’immigrazione e del rimpatrio nelle colonie dei migranti postcoloniali. Da lì a qualche anno, la Gran Bretagna (tra i primi paesi in Europa a farlo) avrebbe chiuso le frontiere ai migranti e tolto la concessione automatica del passaporto britannico per gli abitanti delle ex colonie. Powell, conservatore e poi fondatore del Partito Unionista dell’Ulster, si proponeva come voce istituzionale (era membro del parlamento) del Keep England White inneggiato nelle strade dai movimenti razzisti dell’estrema destra, in particolare dal British National Party, gettando le basi di quelle che saranno le prime politiche razziste di Stato del Secondo dopoguerra, a soli venticinque anni dalla sconfitta del nazifascismo in Europa.
Il leitmotiv del brano – «Get Back to where you once belonged» – si proponeva inizialmente come satira del principale slogan del nazionalismo bianco del momento. Dalle versioni bootleg del pezzo, alcune eseguite nel documentario, altre circolavano in rete già da tempo, veniamo a sapere che uno dei titoli pensati per il brano era «No Pakistanis», e che una delle possibili strofe avrebbe recitato «Don’t dig no Pakistanis taking all the people’s jobs». Il pezzo perse poi un po’ questa connotazione di satira esplicita nei confronti del nazionalismo bianco britannico, prendendo più sembianze tipicamente pop o contro-culturali, quindi ironiche e giocose, dei rapporti di genere tradizionali, forse per timore che qualcuno potesse prendere le parole alla «lettera». E in effetti, queste versioni bootleg di Get Back sono arrivate anche alle orecchie di gruppi rock neonazisti come Stormfront o Battlecry, che ne hanno riproposto delle versioni in senso «letterale».
Nel documentario assistiamo a una delle improvvisazioni più belle del pezzo titolato stavolta Commonwealth e in cui si prende in giro in modo del tutto esplicito Enoch Powell, la tradizione coloniale britannica, l’armamentario retorico dei movimenti anti-immigrazione dell’epoca e il loro nazionalismo bianco. A rendere questi momenti ancora più evocativi e suggestivi vi è anche la scelta di Peter Jackson di aggiungere in sovraimpressione giornali e foto dell’epoca. Il gesto racchiuso in Commonwealth potrebbe essere qui collegato a un’altra presa di posizione antirazzista più nota, ma non sempre presente nell’immaginario sui Beatles: il loro espresso rifiuto, tra i primi nella storia del Rock, a suonare negli Stati Uniti in posti dove bianchi e neri fossero divisi.
Il secondo elemento di rilievo che emerge dal documentario è sicuramente la presenza di Billy Preston. Molti commentatori, in effetti, hanno sentito la necessità di dedicare qualche riga alla sua partecipazione all’evento, e già questo di per sé è sintomatico di un (non registrato) oblio. La maggior parte degli articoli però si sono limitati a ripetere che Preston ha apportato vitalità e armonia alla creatività del gruppo. In realtà, la presenza di Preston non è per nulla secondaria, benché sia rimasta un po’ negletta, musicofili a parte, nelle narrazioni sulla storia e sulla musica dei Beatles. Musicista africano-americano, tastierista (ha suonato anche con i Rolling Stones, Bob Dylan e Aretha Franklin tra gli altri), noto anche come il «quinto Beatle», Preston ebbe un ruolo fondamentale nel raffinamento di diversi brani tanto di Abbey Road quanto di Let it Be, ma soprattutto proprio del pezzo chiave del docu-film, Get Back; tanto che a un certo punto del filmato vediamo Lennon che lo propone come possibile nuovo membro della band. Come si sa, Preston è stato uno dei due musicisti (l’altro è Tony Sheridan) con cui i Beatles abbiano condiviso il nome sull’etichetta di un loro LP, e nel caso della versione 45giri di Get Back si poteva leggere “eseguito dai Beatles con Billy Preston”.
È importante ricordare che i Beatles avevano conosciuto Preston già nel 1962, come spiega Lennon nelle sessions di Get Back, durante la loro tournée ad Amburgo. Preston aveva raggiunto la città tedesca per suonare con la band di Little Richard, e avrebbe incontrato di nuovo i Beatles pochi mesi dopo al Cavern Club di Liverpool in un concerto organizzato da Brian Epstein. In tale occasione, come era già successo ad Amburgo, i Beatles avrebbero suonato come gruppo spalla di Little Richard: un musicista assai ammirato dai giovanissimi Lennon, McCartney e Harrison. Al punto che il primo look da «Teddy Boys» dei Beatles era stato ispirato dalla visione del film The Girl Can’t Help it (1956) di Frank Tashlin, la cui colonna sonora era composta da diverse canzoni di Little Richard, tra le quali appunto Girl Can’t Help it e la famosa «Ready Teddy».


Storia di un brano che ha fatto epoca
TERZA PARTE
La vicenda di Preston presenta alcune analogie con quella di Lord Woodbine, al secolo Harold Adolphus Philips (1929-). Woodbine (prese questo nome dalle sigarette che amava fumare), originario di Trinidad, promoter e musicista (suonava le steel drum e la chitarra), arrivato per vivere in Gran Bretagna proprio a bordo della Empire Windrush nel 1948 dopo aver combattuto con la Raf durante la Seconda guerra mondiale, ebbe grande importanza nella primissima fase dei Beatles, quando ancora si chiamavano Silver Beetles. I «Silver Beetles» fecero alcuni dei loro primi concerti in uno dei locali gestiti da Woodbine, il New Cabaret Artists’ Club di Liverpool, un luogo in cui suonavano spesso artisti dei caraibi, tra cui le stesse band di Lord Woodbine, e cioè la All Caribbean Steel Band e la Lord Woodbine and the Trinidadians, dedite a ritmi tipicamente caraibici come il Doo Wop e il Calipso, due dei generi che hanno profondamente influenzato le prime canzoni create dai Beatles. Lord Woodbine fu tra i principali promotori della famosa tournée ad Amburgo: è stato lui a portarli personalmente in furgone in Germania, e lì suonò con loro nel 1960, nella prima performance tedesca del gruppo. Woodbine aveva convinto i «Silver Beetles» a prendere un batterista per non restare una semplice band dedita allo skiffle. È stato così che Peter Best diventò membro del gruppo.
L’immagine dei primi Beatles era così associata alla figura del loro primo promoter, che all’epoca essi erano noti anche come i «Woodbine’s Boys». Di ritorno a Liverpool, i Beatles cambiarono manager e la figura di Woodbine venne presto archiviata e dimenticata in quasi tutte le analisi e biografie fino a tempi molto recenti. Mentre i Beatles diventavano famosi nel mondo, Lord Woodbine lavorava a Liverpool come tassista, e viveva in uno degli storici quartieri neri della città, quello di Toxteth (noto anche per i violenti riots razziali del 1981, tra i più lunghi e intensi di quel periodo). A testimonianza del loro viaggio insieme ad Amburgo resta una foto scattata all’Arnhem Oosterbeck War Cemetery (cimitero della Commonwealth Graves Commission ad Arnhem, nei Paesi Bassi), in cui compaiono anche gli altri due Beatles dei primordi, poi per diversi motivi scomparsi: Stuart Sutcliffe e il già citato Peter Best. È importante ricordare la breve storia di questa foto, forse scattata da John Lennon: prima sparita dalla circolazione, poi ricomparsa ma con Woodbine cancellato e infine riproposta nella sua versione originale soltanto negli ultimi anni, nella cornice di una nuova serie di studi sulle origini musicali dei Beatles.
Le vicende di Lord Woodbine e Billy Preston possono servire da spunto per interrogare, da una diversa angolatura rispetto al passato, i rapporti «diretti» e «ravvicinati» dei primi Beatles con la musica e la cultura nera, ovvero appaiono come snodi suggestivi per «ritornare» sul ruolo e l’influenza della musica e della cultura nera britannica nella gestazione materiale e simbolica «dal basso», di una delle culture espressive, sociale e musicale, più travolgente del XX secolo. Si tratta di capire qualcosa di più del fatto che suonavano pezzi di Little Richard, Chuck Berry o Larry Williams.
È così che il nostro «ritorno» intende richiamare l’attenzione su un’epoca ben precisa, e cioè il periodo che va dalla formazione al primo grande boom a Liverpool e in Gran Bretagna: dal 1957 (anno dell’incontro tra Lennon e McCartney) al 1963 (anno dell’ultima esibizione al Cavern Club). Tutto quello che accadde dopo, col trasformarsi dei Beatles in un fenomeno culturale di massa globale, è una storia ben nota e del tutto diversa, in cui il loro percorso artistico andrà lentamente a fondersi con la controcultura bianca della swinging London degli anni Sessanta, divenendone una delle sue principali espressioni. Lo stretto rapporto dei Beatles dei primordi con la cultura e la musica nera è un argomento su cui tanto è stato scritto, ma che resta tuttora sfuocato (e offuscato) negli immaginari della cultura pop globale di massa; e questo nonostante gli stessi Beatles abbiano sempre riconosciuto il loro debito verso la black music.
Come suggeriscono alcuni studi più o meno recenti, mettere sotto la lente di ingrandimento la vita sociale e culturale di questo specifico periodo storico a Liverpool può rivelarsi la strategia metodologica più adatta per mettere in discussione lo storico «estrattivismo bianco» che caratterizza le industrie mediatico-culturali occidentali, e cioè quell’aura di anglo-whiteness-imperiale con cui le principali industrie culturali occidentali hanno avvolto il loro mito (si veda, per esempio, il documentario My generation (2017), di David Batty, sicuramente bello ma in cui predomina una visione eccessivamente «cockney» e «bianca» della controcultura plebea rappresentata dal rock inglese degli anni sessanta).
È quanto emerge da una lettura incrociata dei due testi che terremo qui maggiormente in considerazione: Revolution in the Head (1994) di Ian Macdonald, forse lo studioso più importante della storia dei Beatles, e il bellissimo Images of England Through Popular Music. Class, Youth and Rock ‘n Roll 1955-1976 (2013), di Keith Gildart. Quello di Gildart, ex minatore e militante socialista, storico dei movimenti e delle sottoculture operaie inglesi, appare, alla luce dei nostri scopi, di grande interesse. Un ritorno sui Beatles come quello promosso da Macdonald e Gildart può costituirsi inoltre, per dirlo ora invocando il noto libro di Paul Gilroy, come un altro dei modi di rilocalizzare quella presenza black nella storia sociale e culturale britannica storicamente negata e repressa dalla Union Jack e dai suoi dispositivi coloniali di dominio. A partire proprio da questa traccia, lo spunto fornitoci dalla storia del brano Get Back e dalle vicende di Lord Woodbine e Billy Preston potrebbe essere riformulato attraverso la seguente domanda: in che misura l’emergere dei Beatles come fenomeno sociale e musicale popolare può essere visto anche come il prodotto di un singolare intreccio sociale urbano di classe, razza, genere, età e località? O meglio: in che misura il fenomeno più ampio della «beat culture», e in un senso ancora più generale le origini della «pop music», possono essere letti anche come il prodotto di una specifica gioventù operaia e multirazziale non a caso situata nella Liverpool a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta?

La vera storia di un brano che ha fatto epoca
QUARTA PARTE
Mare, docks, navi, marinai, neri, migranti e proletari
Non è un mistero che quello che oggi intendiamo come pop-music ebbe il suo grado zero nella reinterpretazione del Blues e del rock and roll americano emersa in quegli anni nel cosiddetto Merseyside. Migliaia di testi scritti sul tema hanno reso questo dato di fatto un assioma centrale del senso comune della storia della musica pop. Meno noti sono i resoconti sulla centralità di Liverpool – e quindi non solo dei Beatles – in questo processo. Ciò che mettono in evidenza i testi di Macdonald e Gildart è che le caratteristiche storiche di Liverpool, come contenitore geografico-culturale, rendevano la città eccezionale.
Si pensi prima di tutto al porto, uno dei vertici del triangolo della tratta transatlantica di schiavi, ai suoi traffici umani e commerciali; poi alla composizione etnico-razziale della sua popolazione, caratterizzata dalla storica presenza di comunità nere, africane e afrocaraibiche, e da importanti flussi migratori, in particolare irlandesi, cinesi e asiatici, e infine alla sua piuttosto estesa e tradizionale classe operaia autoctona, con la sua robusta identità culturale-regionale (di cui il noto accento Scouse è la principale espressione). Città operaia e plebea, marittima e cosmopolita, multirazziale e postcoloniale, attraversata da forti disuguaglianze e tensioni sociali, razziali e religiose (si pensi ai conflitti tra cattolici e protestanti, presenti anche nella rivalità calcistica della città), così come da diverse identità in conflitto, ma anche da una più che intensa fluidità culturale e politica multirazziale, oggi diremmo meticcia, favorita in quegli anni anche dal primo consumo urbano «giovanile» del Secondo dopoguerra, dalla diffusione sempre più di massa di cinema e radio, dalla crescita della stampa popolare e da un proliferare continuo di luoghi per il divertimento e il tempo libero, come coffee-bar, sale da ballo e da concerto, club musicali, ecc.
Tanto Macdonald come Gildart concordano nell’affermare che è stata proprio questa particolare composizione sociale, razziale e culturale della città ad aver costituito la materia prima – e cioè il soundscape – per la nascita sia della scena beat sia della prima ondata di pop music. Il porto, i marinai, i traffici commerciali, la massiccia presenza nera nella città, l’esistenza di una tradizione operaia popolare piuttosto resiliente, le radio, il cinema, la popolarità del calcio, la fitta rete di bar, club e sale da ballo, e non da ultimo la presenza della più grande base americana all’epoca in Europa (Burtonwood) – al centro di un grande afflusso di diversi tipi di merci americane e della proliferazione di luoghi d’intrattenimento nella città – si sono saldati in una rete di scambi informali che ha creato le condizioni sociali e materiali necessarie alla diffusione e circolazione della musica e della cultura nera nella città e quindi a una sorta di fusione interculturale di diverse identità e tradizioni etniche.
Inoltre, come mostrano entrambi i testi, nelle loro minuziose analisi delle fonti storiche, i giovani della classe operaia bianca, uomini e donne, erano sempre più attratti in quegli anni dalle culture e sottoculture espressive nere, si recavano spesso nei loro locali e quartieri affascinati dalle loro musiche, ma anche dalle loro forme di vita e soprattutto di divertimento.
È stata in una di queste escursioni che i Beatles conobbero Lord Woodbine. Non va dimenticato poi che Liverpool all’epoca ospitava la comunità afro-caraibica più numerosa della Gran Bretagna e che vi era una zona della città – Upper Parliament Street – nota come una piccola «Harlem» caratterizzata da una vita sociale e culturale nera assai vivace. Proprio in questo quartiere nacquero i Roadrunners, una delle prime band di rythm and blues della città e che tra il 1962 e il 1963 fecero da spalla ai Beatles in diversi concerti. Da questo punto di vista, le culture espressive nere, mescolate alle prime espressioni del consumo di massa fordista (riviste, dischi, vestiti, sale da gioco, ecc.), divennero per i giovani bianchi della classe operaia, sempre più distanti dallo stile di vita dei loro genitori, veicoli non solo di evasione, superamento e anche sublimazione dello squallore e della povertà della vita quotidiana, che a Liverpool erano più marcati che in altre grandi città del paese, ma anche di insubordinazione e resistenza nei confronti dei valori e degli stili di vita coloniali, regressivi, puritani, classisti e patriarcali della cultura vittoriana tradizionale.
Per i giovani delle comunità nere il discorso era chiaramente diverso, come si desume dai numerosi riots razziali avvenuti in città proprio in quegli stessi anni. Ciò nonostante, ed è la tesi di Macdonald e Gildart, la nascita della pop music come fenomeno culturale a Liverpool era l’espressione tanto della riproduzione quanto del superamento delle gerarchie di razza, classe, genere e località storicamente costituitesi nella città. In questo senso il singolare microcosmo culturale popolare di Liverpool anticipò quel macrocosmo urbano più generale che avrebbe caratterizzato di lì a poco anche le altre grandi città britanniche. Ma soprattutto, come evidenzia Macdonald, il microcosmo popolare della Liverpool di quegli anni rimase per sempre anche dentro i Beatles: «Quelle immagini e quei suoni sono rimasti depositati nella memoria dei giovani della classe operaia della città e, nel caso dei Beatles, si sono manifestati anche nelle loro esibizioni dal vivo e nelle sessioni di registrazione. Questo è stato particolarmente vero per ciò che riguarda la successiva carriera discografica dei Beatles e in particolare in Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) e White Album (1968), dove hanno attinto a una vasta gamma di stili lirici, images, strumenti e generi musicali». Vi è qualcosa di tutto ciò anche nel documentario di Peter Jackson: molto spesso il gruppo è allegro e coeso quando si ritorna proprio a questa memoria musicale dei primordi, a suonare alcuni dei pezzi che l’hanno maggiormente segnata.
Il ritorno del rimosso
I primi Beatles – come il resto della scena beat – furono dunque espressione di questo singolare mix sociale multirazziale urbano, in un senso e nell’altro. Da una parte, I Beatles si nutrirono e subirono l’influenza dei diversi ritmi della musica nera e africano-americana in città e la combinarono con tradizioni popolari musicali locali, dando vita allo stile della nascente pop-music inglese. Oltre alle già citate vicende di Little Richard, Billy Preston e Lord Woodbine possiamo aggiungere quella di Eddie Amoo and the Chants. Nato nel 1945 a Liverpool, Eddie Amoo era figlio di una famiglia di marinai ghanesi. Nei primi anni Sessanta diede vita a uno dei più noti gruppi di doo-wop della città: The Chants. Si trattava di una band assai particolare, poiché il loro spettacolo consisteva soltanto di canti e cori a cappella, senza musica. Nei primi anni Sessanta, i Beatles suonarono diverse volte con The Chantsn al Cavern Club ed ebbero con loro un rapporto piuttosto diretto, continuo e fluido. Per un periodo, ebbero lo stesso manager, e cioè Brian Epstein. Basta sentire uno qualsiasi dei loro pezzi per capire quanto di loro sia presente nelle prime canzoni dei Beatles. Negli anni Settanta, poi, Eddie Amoo diede vita alla sua band più famosa, il gruppo soul The real thing. Eppure, come nelle vicende citate prima, il suo rapporto con i Beatles è stato riscoperto solo di recente, nell’ambito del crescente interesse degli ultimi tre decenni in Gran Bretagna per la storia dei neri britannici.
Del loro rapporto con The Chants resta soltanto qualche immagine, fra tutte la più nota scattata nel 1964 nel Town Hall di Liverpool, in cui sono ritratti insieme ai Beatles durante un omaggio istituzionale al gruppo di ritorno dopo la loro prima tournée negli Stati Uniti. La storia di questa foto è simile a quella che li ritraeva con Lord Woodbine. Impossibile non leggere queste rimozioni, silenzi e oblii come un prodotto di quella whiteness, o «estrattivismo bianco», che per decenni ha strutturato il campo della cultura pop globale. Su questo fatto vale la pena citare Gildart: «Nel caso dei Beatles e di altri gruppi associati alla ‘scena beat’ il ruolo cruciale giocato dalla musica africano-americana e afro-caraibica deve essere ancora adeguatamente esplorato dagli storici sociali».
The-Chants-UK-A-Thousand-Stars-1963-Liverpool-England-Doo-Wop
Tuttavia se i Beatles furono un importante terminale della musica e della cultura nera a Liverpool, come sostiene Macdonald è vero anche il contrario: «I Beatles hanno agito come un importante influsso nella cultura bianca dell’energia, dello stile e del sentimento dei neri». Essi quindi funsero in quegli anni anche come cinghia di trasmissione dell’espressività culturale e politica della musica nera nella cultura popolare bianca, alimentando in questo modo un’emergente «struttura di sentimento» operaia e multirazziale che da lì a qualche anno avrebbe vibrato e si sarebbe diffusa tra i giovani della classe lavoratrice britannica (uomini e donne) soprattutto come promessa di trasgressione, liberazione, eguaglianza ed emancipazione. Una «struttura di sentimento» plasmata più dalle passioni e dall’affettività, e cioè da quello che oggi potremmo chiamare le politiche dei corpi, che non dal senso o dal discorso. Liverpool, dunque, città operaia e multirazziale, anno zero della ‘beat culture’ e della rivoluzione culturale a cui avrebbe dato luogo la musica pop.
Si tratta di qualcosa che ci annunciava già nel 1964 uno dei più famosi Black-British, e cioè Stuart Hall, in uno dei suoi testi rimasti meno noti, The Popular Arts. Un’enunciazione che non chiude ma apre ancora di più il nostro «ritorno».
*Miguel Mellino insegna studi postcoloniali all’Università di Napoli L’Orientale. Tra i suoi libri, Post-Orientalismo. Said e gli studi postcoloniali (Meltemi) e il recente Governare la crisi dei rifugiati (Derive Approdi)