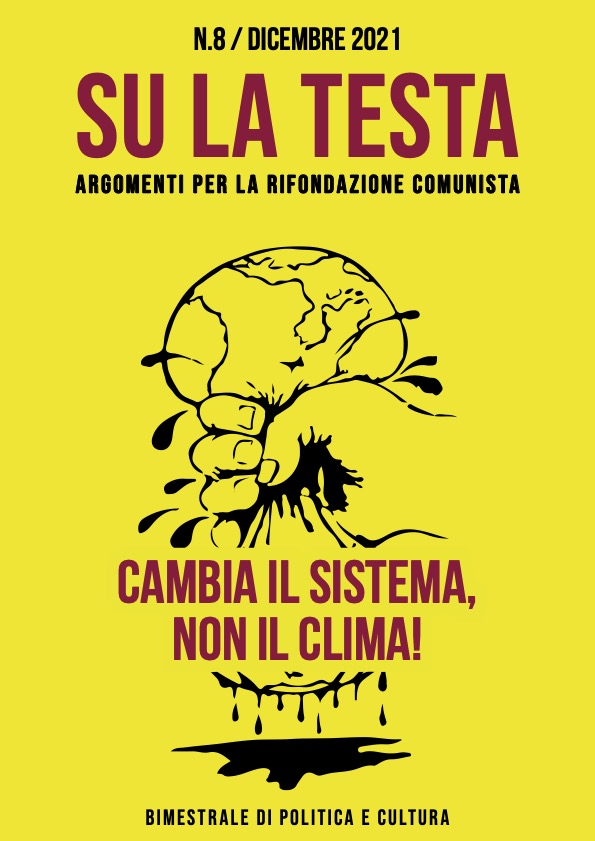UN SITO IN CUI SI STA BENE

L’alternativa della pace: rendiamola possibile!
«Gli apparati di guerra sono un mostro di autoritarismo, e strumento di imperialismo esterno e di repressione interna; e le guerre, fatte in nome della libertà, approdano alla sponda opposta del progressivo aumento dell’accentramento statale e del totalitarismo nel mondo. Le guerre servono i ricchi ed i potenti»
Pietro Pinna, Lettera inviata al Comandante del Distretto militare di Ferrara, 1971
La guerra continua, le notizie sulle bombe nucleari, tattiche o sporche che siano, si rincorrono, la minaccia di un olocausto nucleare cresce. Negli ultimi giorni, la cronaca ci informa dell’arrivo di nuove bombe nucleari in Europa (un ammodernamento) e del fatto che gli Stati Uniti non escludono il ricorso anche “per primi” ad armi nucleari (dal canto suo, la Federazione russa ne prevede l’impiego in caso di “minaccia” all’integrità territoriale): nella vacuità del “per primi” a fronte di ordigni suicidi e delle infinite menzogne delle quali si nutrono le campagne belliche, avanza la normalizzazione della «morte universale» (Manifesto Russel-Einstein, 9 luglio 1955).
La guerra, la guerra “vicino a casa” (la guerra globale, combattuta su differenti scenari e sotto svariati nomi, è tragica realtà da molti anni), entra sempre più nell’orizzonte del quotidiano, con una progressiva narcotizzazione delle coscienze che ondeggia fra acquiescenza, arruolamento, indifferenza. Accettiamo. Accettiamo che gli ucraini continuino a morire sotto le bombe, che le città siano devastate, che da ambedue le parti i soldati muoiano, che gli effetti economici del conflitto rendano viepiù insostenibili condizioni economiche e sociali già profondamente diseguali, che siano rimandate misure improcrastinabili per fermare un riscaldamento climatico i cui effetti viviamo tutti i giorni, che non vi sia altro scenario che una competitività globale aggressiva e violenta, che l’estinzione umana sia parte di un futuro prossimo.
E invece no, non accettiamo! Non accettiamo e guardiamo dietro e oltre, per comprendere e cambiare.
Guardiamo dietro. Non cadiamo nella visione semplicistica della favoletta della guerra per la democrazia o per i valori occidentali (con il suo bagaglio di colonialismo culturale) o dell’interesse per la sorte del popolo ucraino: è una guerra fra imperialismi, che coniuga volontà di potenza e predazione economica in uno scontro per il dominio. La maschera dell’intervento umanitario si è svelata con la sua prima concretizzazione, in Kosovo nel 1999: in Kosovo, non altrove. Del resto, per limitarsi a un esempio, come può essere paladino dei diritti, chi stringe accordi con i peggiori autocratici per esternalizzare le frontiere ovvero delocalizzare la tortura e condurre un vero e proprio genocidio dei migranti? La democrazia è compagna della pace, non della guerra. è la pace l’orizzonte nel quale si può esprimere il conflitto sociale, non la logica identitaria amico-nemico; è la pace il terreno nel quale i diritti vengono garantiti e si possono costruire emancipazione, giustizia sociale e ambientale. La guerra mistifica e distrae dal conflitto sociale e dal contrasto alla devastazione ambientale, compatta artificialmente occultando la radice delle diseguaglianze, veicola sopraffazione e violenza, esprime una logica di dominio. “Pace e giustizia” sono scritte insieme nell’art. 11 della Costituzione. La pace è giusta, non la guerra (https://volerelaluna.it/commenti/2022/10/17/linganno-della-pace-giusta/). La guerra, ancora, ci abitua alla militarizzazione: alla violenza, al controllo, a una propaganda omologante. Si affacciano alla mente le distopie dove pochi privilegiati si chiudono in cittadelle fortificate mentre intorno, in un mondo devastato da disastri climatici, un controllo feroce presidia la disuguaglianza. «Totalitarismo e dittatura all’interno significano inesorabilmente nazionalismo e guerra all’esterno» (Calamandrei), e viceversa, si può aggiungere; tanto più oggi, con un governo che all’aggressiva competitività del neoliberismo, al bellicismo atlantista, aggiunge un escludente nazionalismo identitario sotto l’egida della triade “Dio, patria, famiglia”, proiettando sul futuro le ombre del passato.
Guardiamo oltre. Le coscienze sono ormai così anestetizzate, così assoldate nel pensiero unico? È difficile mettere in discussione l’unica soluzione pervasivamente propugnata come possibile: “più guerra”, ripetuta, spesso anche “in buona fede”, come un mantra. Ma occorre continuare a farlo: per chi è vittima della guerra, in primo luogo, ma anche per la democrazia, del presente e del futuro, se non per la stessa possibilità di futuro. Manteniamo la capacità di immaginare e di lottare. Diciamo no alla guerra e chiediamo la pace: il cessate il fuoco e una conferenza internazionale per la pace. E poi il disarmo… E, aggiungo, anche l’“intoccabile”: il rifiuto di un’alleanza (la NATO), che dal 1999 prevede «operazioni d’intervento in caso di crisi non previste dall’art. 5» (difesa) e in «tutte le possibili evenienze», con una metamorfosi che si estrinseca nella guerra al terrorismo (Afghanistan 2001) e nella guerra preventiva (Iraq 2003), non rispettando i parametri della guerra di legittima difesa (l’unica ammessa dalla nostra Costituzione). È questa la via per una comunità internazionale fondata su pace e giustizia (art. 11 Costituzione), per la costruzione di democrazie. Utopia? Senza speranza la storia si immobilizza nella riproduzione di un eterno presente ed è proprio la storia, con la sua dialettica, che invece ci mostra come il cambiamento sia possibile, possa farsi realtà. I «discordi» oggi sono disposti «in un pulviscolo individuale e disorganico» e una sola forza, controllando gli «organi dell’opinione pubblica: giornali, partiti, parlamento», modella «l’opinione e quindi la volontà politica nazionale» (Gramsci). È vero, ma il pulviscolo può unirsi, può farsi forza organizzata per dire no alla guerra, con gli stessi toni energici con cui nella Costituzione si è scelto di ripudiare la guerra: ripudiarla, non condannarla o rinunciare ad essa, perché ripudio è un termine più energico, ha più forza.
Esigiamo la pace: come nel fine-settimana del 21-23 ottobre con le tante piazze sparse per tutto il Paese (https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2022/10/21/di-nuovo-in-piazza-il-popolo-della-pace/), è ora – il 5 novembre 2022 a Roma – di far sentire, forte, la voce del movimento pacifista. D’accordo, non sarà come nel 2003, quando centodieci milioni di persone in tutto il mondo, tre a Roma, hanno reso il movimento pacifista “seconda potenza mondiale”, ma è ora di costruire una pressione dal basso. La pace non è una resa. La resa è pensare che non vi sia alternativa all’escalation, al combattimento … sino all’ultimo ucraino; resa è non usare la ragione per comprendere chi si giova di questa guerra. Esistono altre vie per costruire una pace che non sia quella dei cimiteri, edificata sugli orrori della guerra, per fermare la corsa folle all’utilizzo di armi nucleari. Chiedere con una grande manifestazione dal basso il cessate il fuoco e una conferenza internazionale di pace è il primo passo. Un passo per la pace, un passo di democrazia, un passo per invertire la rotta e per andare verso un altro futuro.
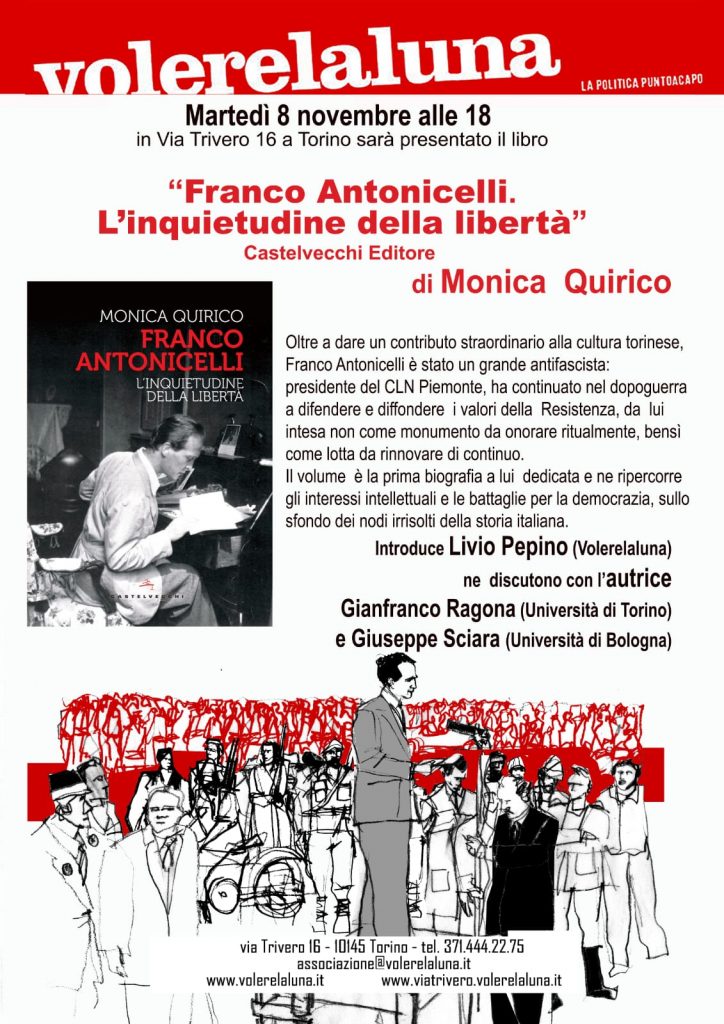
<<<<<<<<< <<
«Perché non possiamo non dirci comunisti»
24-10-2022 – di: Francesco Coniglione
Tempo fa mi è stato dato modo di vedere in un balcone sventolare una bandiera del PCI con falce, martello e stella, sovrapposta a una bandiera arcobaleno simboleggiante la pace, in una città come Sesto San Giovanni, una volta ritenuta la Stalingrado d’Italia e ora governata dalla Lega. Avevo pensato a come esistessero ancora vecchi comunisti asserragliati in un fortino, all’interno di un ambiente ostile. Nel parlarne con un amico, questi mi ha posto ironicamente e provocatoriamente la domanda: “nostalgia?”. Essa mi ha dato da pensare su di me, ma anche sulle possibili motivazioni che avevano potuto spingere ad esibire quella bandiera.
Una riflessione che è stata anche stimolata dalle frequenti accuse di essere dei “cripto-comunisti”, rivolte a chi esprime qualche pensiero eterodosso sull’odierno tragico conflitto bellico, e quindi di avere nostalgie verso la vecchia URSS, della quale si vedrebbe una sorta di proseguimento nell’odierna Russia. Ciò dà da pensare non tanto per la inesattezza della diagnosi (solo chi è totalmente accecato potrebbe confondere la Russia di oggi con la vecchia URSS), quanto perché evidenzia un diffuso modulo di pensiero: che il “comunista” sia contraddistinto dal suo essere comunque e ovunque dalla parte della dittatura e dell’oppressione, una volta quella staliniana, oggi quella putiniana. Infatti, entrambe le realtà (quella dell’URSS e quella dell’odierna Russia) hanno in comune, secondo questo modo di pensare, l’essere due regimi dittatoriali, autocratici e quanto di peggio si possa dire (anche qui ignorando le differenze per privilegiare un pensiero assimilante e incapace di fare distinzioni). Ergo, i comunisti sono per loro natura e convinzione degli antidemocratici e il comunismo è di per sé una dottrina da respingere allo stesso modo di come si respinge il nazifascismo. La vecchia dottrina degli “opposti estremismi” (elaborata al tempo delle Brigate rosse) ha così una sua rivisitazione alla luce degli eventi contemporanei. Tuttavia questa linea di pensiero ha un inconveniente decisivo, specie nel momento in cui si fa il confronto con il nazismo. Essa non distingue le idealità e le motivazioni di fondo che hanno alimentato l’idea comunista da quelle che ne sono state le sue realizzazioni concrete, nei paesi del cosiddetto “socialismo reale” dell’Europa orientale (lasciando da parte Cuba, Cina e altre esperienze simili, per non complicare il discorso). Il comunismo come visione del mondo e concezione della vita ha origine ancor prima del pensiero di Marx, nella realtà e nella prassi di lavoratori e uomini che hanno lottato per la giustizia sociale e contro l’accumulo di ricchezze e potere in poche mani. L’ideale della distribuzione egualitaria dei beni è stata un modo per protestare contro il loro possesso monopolistico. Il comunismo (nella sue varie declinazioni, come socialismo e persino anarchismo) è stato quindi – anche nell’elaborazione successiva fattane da Marx ed Engels – un movimento che ha sempre sostenuto l’eguaglianza, la lotta contro tutti i tipi di ingiustizie, la democrazia e la rappresentanza di tutti gli interessi, la solidarietà, la parità di tutti gli uomini/donne indipendentemente dalla razza o dal genere, la premura verso i più diseredati, la necessità quindi di una istruzione pubblica per tutti, di una sanità universale non dipendente dalle ricchezze di ciascuno, di una vecchiaia dignitosa e assistita, infine la pace e il ripudio di ogni tipo di guerra. Per questi ideali hanno lottato per centinaia di anni migliaia di uomini e donne; si sono battuti subendo repressione, carcere, violenza e morte, tutti animati dall’idea che fosse possibile un’umanità migliore, più giusta, più solidale, più pacifica. Un ideale che, come hanno sostenuto in molti, è già inscritto nella originale predicazione di Cristo, che così sarebbe il primo “socialista” della storia, e che è stato ripreso da altri eminenti cristiani, come san Francesco, per citarne solo uno; un ideale che persino i suoi naturali avversari (i ricchi e i potenti) ritengono bello e buono, pur definendolo un’utopia, impossibile da realizzare. Ebbene se comunismo significa tutto ciò – come penso sia – allora non esito a dichiararmi comunista.
Ma il comunismo è anche stato qualcosa di assai diverso quando lo si è cercato di realizzare con la violenza in un paese arretrato, sulla base di una teorizzazione (quella di Lenin) che innovava in modo decisivo il pensiero di Marx (anche sviluppando germi in esso già presenti) allo scopo di giustificare la presa di potere di un partito organizzato secondo stile militare. La necessità di mantenere con tutti i mezzi il potere conquistato – giustificata con la teoria della “dittatura del proletariato” – ha condotto a un sistema tra i più oppressivi mai realizzati nella storia dell’umanità, in quanto in questo caso le tre tradizionali sfere in cui si articola l’autonomia della società civile – economia, cultura/spiritualità, politica – sono cadute tutte nelle mani di un unico soggetto che ha finito per governarli non più nell’interesse del proletariato (come ancora ci si illudeva nei primi anni della rivoluzione) ma di un ceto nel contempo formatosi, che ha ricevuto il nome di “nomenklatura”. Insomma, in tal modo la ferrea legge del potere – ovvero la tendenza ad autoperpetuarsi ed espandersi con la formazione di un vero e proprio ceto politico che cerca di detenerne o controllarne tutte le espressioni – si è venuta ad attuare senza alcun freno da parte della società civile e senza nessun altro contrappeso, diversamente da quanto avvenuto nelle società liberal-democratiche per circostanze storiche assai specifiche, che qui non si possono esaminare. Ebbene, se il comunismo è inteso in questo modo, allora io non esito a dichiararmi anticomunista.
Quanto detto ci permette di effettuare una differenza fondamentale col nazismo (e il fascismo, nonché con tutti quei movimenti di destra che in modo più o meno soft a tale esperienza guardano con indulgenza). Esso non ha conosciuto tutta quella elaborazione e quella storia che abbiamo prima descritto a proposito del comunismo. È nato, sin dai suoi documenti fondatori (il Mein Kampf di Hitler) con il culto della violenza, la predicazione della discriminazione razziale (da cui la sua pratica realizzazione con la Shoah), l’irrisione verso la solidarietà e la pace (virtù di popoli deboli e imbelli, frutto dell’“invidia sociale”, in un’utilizzazione speciosa di Nietzsche), l’esaltazione della forza, del coraggio, della fedeltà verso un capo indiscusso e incarnante lo spirito del popolo (il Fuhrer, il Duce), del disprezzo della ragione e della comprensione degli altri. Basta leggere non solo il testo citato, ma anche gli altri scritti degli ideologi del nazismo (come il famoso testo di Alfred Rosenberg o gli altri che in qualunque storia del nazismo sono menzionati come suoi ispiratori culturali, ad es. i classici lavori di George Mosse) per avere contezza di ciò. E lo stesso si può dire del fascismo, per il quale basti l’esempio di un suo sostenitore (per fortuna poco ascoltato) come Julius Evola, che certo non può ritenersi un propugnatore della pace, dell’eguaglianza, della solidarietà e di tutti gli altri caratteri prima definiti come propri del comunismo (senza voler qui mettere in campo l’antisemitismo) e al quale ancora oggi guardano con simpatia molti degli attuali esponenti della destra. Non solo, ma il nazi-fascismo è esordito – ne abbiamo un esempio in Italia – come movimento violento contro i lavoratori: distruggendo le camere del lavoro, negando loro i diritti sindacali e mortificandoli in ogni modo, a vantaggio del ceto padronale e industriale; i suoi simboli sono lugubri, esaltano la morte e il sacrificio, non certo la pace e la carità. Certo v’è chi cita qualche fascista o nazista “di sinistra” (o ricorda il famoso e mai realizzato “corporativismo”), ma questi sono fenomeni di assai scarso peso e successivi alla sua nascita e realizzazione concreta; non appartengono di certo ai suoi ideali originari.
Ecco perché è sbagliato accomunare tout-court comunismo e nazi-fascismo: se tale assimilazione può avere una giustificazione per il comunismo visto nella sua incarnazione concreta, cioè quando si comparino i due sistemi politico-sociali (pur nelle notevoli differenze), esso è tuttavia fuori bersaglio quando se ne studino le motivazioni ideali, le matrici culturali e gli obiettivi che essi si erano assegnati. Certo resta un importante e interessante problema storiografico da studiare, ovvero quello di come sia possibile che un movimento come il comunismo, nato con così belle intenzioni, si sia trasformato in un sistema oppressivo; ma è un quesito che non riguarda solo il comunismo, ma si pone anche per il cristianesimo e molti altri movimenti che, dopo un inizio improntato a ideali di fraternità e accoglienza, sono poi degenerati in istituzioni violente e oppressive, come nel caso dei francescani che han finito per essere inquisitori e processare i propri stessi confratelli, condannandone quattro al rogo (l’episodio del maggio 1318 a Narbona). Forse una maggiore attenzione alle dinamiche del potere sarebbe in questo caso utile.
Ebbene, se oggi mi sento del tutto solidale con le idealità del social-comunismo (non ho fatto la differenza, ma ovviamente essa esiste dal punto di vista storico) e ritengo esse debbano ancora indicare la terra d’utopia che deve guidare la nostra prassi quotidiana, nel rispetto dei principi democratici e quindi senza la deriva totalitaria avutasi in Russia, non potrei mai essere un nazifascista, la cui ideologia e prassi cerco e mi sforzo di combattere con i mezzi non violenti che ho a disposizione e conformemente a quanto dettato dalla Costituzione italiana. Ecco, mi sento di interpretare quella bandiera sventolante sul balcone di Sesto San Giovanni come il segno che questi ideali non sono ancora tramontati e che c’è qualcuno che crede in essi, a dispetto di chi distingue tra “noi” e gli “altri2, tra “casa nostra” e la condizione di chi è “senza casa” e viene a bussare alla sua porta. La differenza in fondo è tra chi decide di aprire quella porta e chi invece è sordo al bussare, restando rinserrato all’interno della sua casa, nel suo egoismo e nella sua solitudine.
L’umanità a un bivio: intervista a Emiliano Brancaccio
31-03-2022 – di: Alberto Deambrogio e Monica Quirico
All’impegno accademico come docente di Politica economica presso l’Università degli studi del Sannio (Benevento), Emiliano Brancaccio affianca un’intensa attività di opinionista. Gli abbiamo rivolto alcune domande sul suo ultimo libro, Democrazia sotto assedio. La politica economica del nuovo capitalismo oligarchico (Piemme, 2022), in cui l’autore, partendo dalle ricerche empiriche condotte da lui e da altri studiosi, offre a un pubblico non specialistico una ricognizione sul rapporto tra capitalismo e democrazia (per il video dell’intervista cfr. https://www.youtube.com/watch?v=3cpx1VXTLqg&t=4265s ).
Il filo conduttore del volume è l’invito a riscoprire quella che Brancaccio individua come la più importante tra le leggi tendenziali di sviluppo del capitalismo enucleate da Marx, quella della crescente centralizzazione dei capitali; un processo che, all’interno degli Stati nazionali, si riverbera in uno scontro finanziario e politico tra le diverse frazioni della borghesia (schematizzando: fra globalisti e sovranisti), mentre a livello internazionale si traduce in una competizione tra diversi attori geopolitici che, per assicurarsi quote crescenti del mercato globale, sono disposti a spingersi fino al conflitto militare.
Alla luce di questa analisi, la nostra discussione non poteva che cominciare dalla guerra in corso. L’evidenza empirica – ci spiega l’Autore – è «così sconcertante da indurci a riabilitare, a recuperare una teoria strettamente collegata al concetto di centralizzazione capitalistica nel senso di Marx: la teoria dell’imperialismo, una categoria che ci aiuta a capire che la guerra economica genera squilibri di tale portata, processi di sbilanciamento tra capitali forti e capitali deboli, tra capitali in attivo e capitali in passivo, tra creditori e debitori, da tramutarsi, a lungo andare, in potenziale conflitto fra nazioni, fino a sfociare in guerra militare». L’invasione russa dell’Ucraina, prosegue Brancaccio, può essere definita imperialista non solo perché non ha alcuna “nobile ragione” da addurre, ma anche perché nasce da lontano, ossia dalla crisi di un’altra “soggettività imperialista”, quella degli USA – e dei loro alleati – che l’Autore riconduce a un’inarrestabile crescita del debito estero, concomitante all’espansionismo militare e arrivata ormai a un punto di rottura.
Inevitabile a questo punto la domanda su come superare lo iato tra le evidenze teorico-empiriche della centralizzazione dei capitali e l’attuale condizione non solo materiale, ma anche culturale e di autopercezione di quello che dovrebbe costituire il soggetto trasformatore, ossia il frastagliato mondo del lavoro salariato (e di quello pseudo-autonomo). Da un punto di vista oggettivo, «la centralizzazione dei capitali – sottolinea Brancaccio – conduce sotto molti aspetti a un’uniformizzazione di classe, intesa come convergenza [al ribasso] nelle condizioni materiali di lavoro e di vita a livello internazionale». Chiediamo all’Autore se l’innegabile livellamento verso il basso delle garanzie giuridiche, delle retribuzioni e delle procedure di lavoro renda davvero superflua la prospettiva dell’intersezionalità, con la sua insistenza sulla concatenazione di forme di oppressione diverse (perché fondate non solo sulla classe, ma anche sul genere, l’etnia ecc.). La sua risposta – che farà discutere – è che tale approccio riflette una fase storica ormai conclusa, in cui il comando capitalistico veniva effettivamente esercitato attraverso il divide et impera. Oggi «il capitalismo ci emancipa dalle differenze, ma ci emancipa nello sfruttamento», osserva l’autore, che nondimeno ammonisce a non cadere in un rozzo positivismo. Il richiamo è a Benjamin e alla sua critica «di ogni tentativo di rappresentazione della storia secondo i canoni di modelli matematici di tipo lineare». La legge tendenziale della concentrazione dei capitali, che – ricorda l’autore nell’intervista – proprio perché “tendenziale” non è lineare, racchiude in sé una contraddizione potenzialmente catastrofica, «che pone un problema di soggettività rivoluzionaria», un recupero dell’idea di noi stessi come “attesi”, ossia la consapevolezza del nostro passato e di un nostro possibile destino altro; una condizione, questa, necessaria per arrivare preparati al bivio che ogni catastrofe dischiude.
Le linee di sviluppo, scientificamente riscontrabili, del capitalismo chiamano così in causa la componente messianica del marxismo. Questo non significa che la strada sia spianata: la tendenza oggettiva all’uniformazione si accompagna ad altre tendenze che non sono pacificamente risolutive, anzi, sono foriere di catastrofe, appunto. Non si può quindi pensare – ironizza Brancaccio – di sedersi sulla riva del fiume e aspettare di veder passare il cadavere dell’accumulazione capitalistica; occorre anzi costruire una lotta per l’egemonia, gramscianamente parlando, che marchi la sua distanza dalle forme “codiste” – così le definisce l’Autore – ossia forme che in ultima istanza servono gli interessi degli apparati capitalistici, perché prescindono dalla centralità della classe operaia; una categoria, quest’ultima, che certamente va ripensata (per includere anche figure apparentemente distanti dall’operaio classico), ma assolutamente mantenuta.
«La scoperta scientifica di leggi oggettive, impersonali, di riproduzione del capitale non è in contraddizione con la categoria diciamo pure scientifica di egemonia»; i due movimenti vanno di pari passo e quello che oggi si osserva – chiarisce Brancaccio – è «un movimento oggettivo, in particolare una tendenza verso la crisi capitalistica, e contestualmente una serie di problematiche nella pratica egemonica». Lo sbocco di tale crisi è, ovviamente, indeterminato e non possiamo escludere che la nuova forma egemonica di un sistema in cui la competizione economica trascende in conflitto militare assuma il volto del neoliberismo autoritario.
Per neutralizzare lo scenario catastrofico che può scaturire dalla crisi capitalistica, Brancaccio propone una pianificazione democratica. È un ritorno al keynesismo, gli domandiamo? La sua risposta è netta: non sussistono più le condizioni storiche che lo resero possibile; esso rappresentò infatti la risultante dialettica dello scontro tra capitalismo e socialismo. Oggi tuttavia questa tensione tra due campi contrapposti è del tutto assente ed è per questo – precisa l’autore – che qualsiasi recupero del keynesismo non può che assumere tratti reazionari, concretizzandosi in una politica economica volta a frenare la tendenza alla concentrazione dei capitali, per tenere in vita quelli piccoli.
La pianificazione di cui ci parla Brancaccio non è l’evocazione di un fantasma del passato: «in forme assolutamente primordiali, embrionali, prodromiche la pianificazione è già presente, come pezzo della crisi del capitale»: ad esempio, la centralizzazione del capitale finanziario porta con sé anche una centralizzazione dei processi decisionali. «Questo è evidentemente lo stadio embrionale di una crisi del capitalismo, anche di una crisi ideologica»: che ne è infatti della libera concorrenza tra una miriade di attori? La tendenza alla “ossificazione burocratica” peraltro non è una prerogativa dello stalinismo, è insita anche nella pianificazione capitalistica; del resto, non mancano nella storia – e nel presente – gli esempi di capitalismo integralmente lesivo di ogni libertà che non sia quella… del capitale, con buona pace della narrazione dominante. In che senso allora il piano può diventare garanzia di libertà? «La libera espressione dell’individualità, cara a Marx […], si manifesta nella repressione della libertà finanziaria del capitale, quindi in ultima istanza in un comunismo pianificatore della tecnica», puntualizza Brancaccio, invitando a recuperare le intuizioni marxiane ma anche quelle di Alexandra Kollontaj.
Chiudiamo sollecitando la sua opinione sul movimento per il clima e sulla sinergia con altri movimenti sociali. L’emergenza climatica, riconosce Brancaccio, costituisce «la rappresentazione scenograficamente più efficace della categoria della catastrofe» e in quanto tale solleva il tema della rivoluzione: il capitalismo infatti è costitutivamente incapace di affrontarla. Non del mercato, ma di una rivoluzione pianificatrice c’è bisogno. Di questa necessità, nota l’autore, non tutto il movimento per il clima è consapevole; quanto all’unificazione delle lotte intorno alla questione ambientale, Brancaccio ritiene che per ogni movimento rivoluzionario sia fondamentale partire dalla percezione delle persone, per poi arrivare a visioni generali. «Dovremmo evitare – è la sua conclusione – di correre frettolosamente verso un tentativo di riunificazione intorno alla visione della catastrofe climatica», tornando piuttosto a costruire modelli di ricomposizione delle rivendicazioni sociali che partono dal vissuto delle persone, un vissuto plasmato dalla divisione in classi.

su gentile concessione dell’associazione Volere la luna


Stalin e Ivan il terribile: le bugie della guerra
di: Loris Campetti
Chi decide di dichiarare guerra al “nemico”, nel nostro caso la Russia, dovrebbe prima ascoltarlo, per capire meglio chi è e dunque imbracciare l’arma giusta per combatterlo. Anche chi sostiene le ragioni di Putin, convinto che il nemico non è lui ma l’altro, quello che parla una lingua vicina all’inglese e fa guerra per interposta Ucraina, dovrebbe sapere bene chi è colui che difende. Altrimenti si combatte, di qua o di là della barricata, solo perché si ha uno spasmodico bisogno di avere un nemico.
Cosa dice Putin, per contestualizzare la guerra contro l’Ucraina e convincere i suoi cittadini, i suoi soldati e i suoi intellettuali che si tratta di guerra giusta? Dice che la causa di tutti i mali viene da lontano ed è attribuibile a Lenin e ai bolscevichi che scegliendo lo stato federale hanno dato dignità e autonomia a Paesi vassalli della Grande Russia, accreditando per esempio l’Ucraina come stato e gli ucraini come popolo e per di più, hanno generato una Costituzione che consentiva ai suddetti stati-non stati di decidere se restare nell’Unione sovietica o abbandonarla scegliendo l’indipendenza. Oggi invece, l’interpretazione scelta dai media italiani, europei e anglosassoni per definire Putin è che il tiranno russo non sarebbe altro che un figlio o forse figlioccio di Stalin e dell’Urss. In questo modo si mette in campo la suggestione dell’orso sovietico, nel tentativo di stimolare paure ancestrali e ricordi, immagini antiche della guerra fredda, scomuniche papali ai comunisti, quando i manifesti davanti ai seggi elettorali ammonivano: «Dio ti vede Stalin no», e che i comunisti mangiavano i bambini mentre ora hanno cambiato menù e si accontentano di ammazzarli con le bombe lanciate contro gli ospedali. La lettura dell’originale del Putin-pensiero andrebbe consigliata anche a chi pensa che in fondo in fondo Vladimir ha ragione e spera in una sua vittoria sul campo contro i nazisti ucraini. Parlo di una minoranza che alberga nelle fila della sinistra, di chi, e ne conosco qualcuno, è incattivito dalla nostalgia per il due blocchi, Usa contro Urss, e rimpiange l’equilibrio del terrore terminato con la fine del socialismo reale. Ma nel tentavo espansionistico di Mosca vede un film sbagliato: Putin non è il capo di uno dei due blocchi che erano anche portatori di modelli sociali, economici e culturali diversi, oggi di blocco ne è rimasto uno solo. Tralascio il fatto che la paura, più che legittima, dell’egemonismo americano non può spingere dalla parte di chi si vorrebbe che fosse ma non è Giuseppe Stalin. Ma questa è una riflessione personale di chi con lo stalinismo ha rotto ogni sia pure solo ereditato rapporto appena è stato in grado, anagraficamente, di intendere e volere. Che cosa può mai avere a che fare con qualsivoglia idea di sinistra uno che solo quattro anni fa ha messo fuori legge il sindacato metalmeccanico, complice di aderire allo stesso sindacato multinazionale di cui fanno parte Fiom, Fim e Uilm e un’altra cinquantina di organizzazioni in giro per il mondo? Il tribunale di San Pietroburgo lo accusa di aver raccolto firme per modificare l’orrenda legislazione russa sul lavoro, e tanto è bastato perché fosse messo a tacere. Putin fa semplicemente quel che da noi Confindustria e parte non secondaria della politica sognano ma non riescono a realizzare.
Putin non è figlio né figlioccio di Stalin, tampoco di Lenin. Semmai è un figliastro, o meglio un nipotastro della cultura imperiale zarista, per liberarsi della quale Lenin e i bolscevichi fecero la rivoluzione cosiddetta d’ottobre. Non c’entra niente, Putin, con l’ottobre rosso perché di rosso ha solo le mani sporche di sangue. Scriveva Ivan IV Vasil’evic detto Ivan il terribile in una lettera ad Andrej Kurbskj, il nobile russo prima amico e poi oppositore: «Tutti i sovrani russi sono autocrati e nessuno ha il diritto di criticarli, il monarca può esercitare la sua volontà sugli schiavi che Dio gli ha dato. Se non obbedite al sovrano quando egli commette un’ingiustizia, non solo vi rendete colpevoli di fellonia, ma dannate la vostra anima, perché Dio stesso vi ordina di obbedire ciecamente al vostro principe». Vi ricorda qualcuno, questo zar di tutte le Russie?
Solo partendo da un principio di realtà, solo con la cultura che dovrebbe averci vaccinato rispetto al veleno delle bugie di guerra, è lecito prendere posizione, a favore, sia pur con tutti i distinguo, o contro la guerra di Putin. Dando a Putin il suo vero nome, Ivan IV Vasil’evic e non Iosif Vissarionovic Dzugasvili, per esempio, si può comunque dire che armare gli ucraini è una follia che alimenta nuova guerra e non allunga la vita di un solo bambino che ha avuto la sfortuna di nascere e crescere sotto le bombe. E sempre chiamando per nome Putin si può, al contrario, sostenere il dovere morale di aiutare con ogni mezzo la resistenza ucraina (possibilmente senza impropri e inaccettabili paragoni con la Resistenza al nazi-fascismo), a prescindere dalle conseguenze per l’Ucraina e l’umanità.
Anche le bugie non sono più quelle di una volta, è come se le loro gambe si fossero allungate a dismisura. Le bugie e i non detti, i non visti. Delle stragi di Putin oggi vediamo tutto, i civili ammazzati ci vengono sbattuti in faccia ora dopo ora tra una pubblicità del farmaco contro la prostata e un varietà. I 14mila russofoni ammazzati nel Donbass negli ultimi otto anni, invece non li abbiamo visti, come non abbiamo commentato i cinquanta morti ammazzati dentro e fuori la sede sindacale di Odessa dai nazisti del battaglione Azov, come ci ricorda il presidente di Pax Christi, il vescovo Giovanni Ricchiuti. Questo vuol dire che i crimini dell’uno pareggiano quelli dell’altro? Al contrario, i crimini dell’uno si sommano a quelli dell’altro in una spirale criminale in cui le responsabilità maggiori sono del più forte, cioè della Russia, senza però assolvere il più debole. Senza dimenticare. Dire che prima delle foibe ci sono stati i crimini dei fascisti italiani contro il popolo jugoslavo non vuol dire che le foibe siano state una risposta giusta, ma è indubbio che siano state una risposta. Così come ricordare le vittime del Donbass non significa che le bombe di Putin sull’Ucraina possano nobilitare a “guerra giusta” la sporca guerra di oggi. I bambini del Donbass valgono come quelli di Kiev e come i bambini di tutto il mondo e di tutte le guerre. Gli uni e gli altri vanno salvati e per farlo, oggi, bisogna fermare una guerra combattuta intorno, e dentro, le centrali nucleari. Anch’esse andrebbero salvate, e poi magari chiuse. Armare la resistenza ucraina contro una potenza che oltre alle centrali ha anche le bombe nucleari, avvicina o allontana la pace in Ucraina e nel mondo?
A chiamare Putin Stalin e bolscevichi i soldati russi si fa un falso storico, così come a chiamare il presidente russo Hitler, per di più banalizzando quel che è stato il peggiore dei crimini del Secolo breve: lo sterminio di ebrei, rom, antifascisti, handicappati, omosessuali. Si può ragionare – noi che il rumore delle bombe lo sentiamo solo in tv, speriamo non solo per ora – e persino litigare a partire da un principio di realtà, evitando di aumentare la quantità di bugie di guerra messe in circolazione da un’informazione embedded, al di qua e al di là del nuovo muro?
Un’ultima considerazione. La prima vittima della guerra è la verità. Ma c’è una verità almeno che andrebbe salvaguardata: la guerra rende chi combatte per la libertà sempre più simile a chi combatte per cancellarla, mina nel profondo la democrazia e le coscienze. I partigiani l’avevano capito benissimo, e per questo vollero fortissimamente l’articolo 11 nei principi fondamentali della Costituzione: «l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>
L’università nello stato di emergenza
di: Società per gli Studi sul Medio Oriente
«Fare un passo in più con il pensiero, pensare in modo diverso, verificare i nostri pensieri e riconoscerne i limiti e poi superarli, questa è la libertà di pensiero. Il nostro pensiero non diventa libero quando lo usiamo per predicare la libertà, ma piuttosto quando pensiamo liberamente e continuiamo a lavorare per espandere i limiti del nostro stesso pensiero, quando consentiamo agli altri di pensare per sé stessi, quando aggiungiamo ogni volta qualcosa di nuovo e andiamo oltre, quando riconosciamo i nostri limiti e li superiamo».
Yassin al-Haj Saleh, Libertà: casa, prigione, esilio, il mondo, Terra Somnia, 2021, p. 59.
La ministra dell’università e della ricerca Cristina Messa ha sconfessato ieri (2 marzo 2022) l’intempestivo zelo della rettrice e del prorettore alla didattica dell’università di Milano Bicocca, che avevano deciso di rimandare un corso su Dostoevskij allo scopo di «evitare ogni forma di polemica, soprattutto interna, in quanto è un momento di forte tensione». La ministra ha infatti puntualizzato che «il Ministero promuove il ruolo delle università come luogo di confronto e di crescita comune, ancora di più in una situazione così delicata». Questa dichiarazione, così come la pronta reazione dei politici, è ragione di sollievo. Questa vicenda, tuttavia, resta comunque il sintomo dell’attuale incertezza sul ruolo dell’università e sugli spazi di discussione democratica al suo interno e più in generale nella società. Come ha commentato Serena Vitale, i responsabili dell’Università Bicocca, con la loro scelta iniziale, volevano essere «più realisti del re». Lo hanno fatto allineandosi maldestramente alle pressanti spinte all’unanimismo che la Commissione Europea e il governo italiano stanno facendo con mezzi retorici e legali. Il timore di “polemiche” dell’Università Milano Bicocca è infatti contemporaneo alla decisione della Commissione Europea di mettere al bando in Europa i media finanziati dallo stato russo, che Ursula von der Leyen ha giustificato dichiarando «non li lasceremo seminare i semi della discordia nella nostra Unione» (Anna Maria Merlo, Il Manifesto 3 marzo 2022).
“Coesione”, “fermezza”, “unità” sono anche parole chiave del discorso del 1° marzo con cui il Presidente del Consiglio italiano ha annunciato al Parlamento, citando il neo-conservatore americano Robert Kagan, la fine dell’“illusione” pacifista – alla lettera «Come aveva osservato lo storico Robert Kagan, la giungla della storia è tornata, e le sue liane vogliono avvolgere il giardino di pace in cui eravamo convinti di abitare».
Chi abbia seguito con un minimo di attenzione gli ultimi trent’anni di guerra in Medio Oriente non si è mai cullato in queste illusioni. Chi lo fa professionalmente nel nostro paese, come gli iscritti all’associazione di cui facciamo parte – SeSaMO, sta facendo da anni l’esperienza di una crescente divaricazione fra la retorica ufficiale e della comunicazione di massa improntata allo “scontro di civiltà” e gli strumenti di analisi scientifica propri dei molteplici approcci disciplinari coinvolti nel nostro ambito di studi (scienze politiche e sociali, storia medievale e contemporanea, lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia, linguistica, antropologia, storia intellettuale e religiosa; studi giuridici ed economici, geografia ecc.) ‒. Questa divaricazione non è negativa nella misura in cui riflette una distinzione di compiti fra il potere esecutivo e la ricerca scientifica. Se i governi non possono fare a meno di slogan per giustificare le loro scelte, è precisamente compito dei ricercatori e dei docenti fornire diversi strumenti di lettura della realtà. Se i governi predicano la libertà, ricercatori e docenti hanno il compito di praticarla. Questo esercizio non è mai stato facile. Non è uno status ma una vocazione. Molti fattori, nell’università-azienda, contribuiscono a mortificarla. Le reazioni dei docenti sono state minime. Un acuito senso di precarietà contribuisce a intimidire e ad aggravare l’isolamento di chi lavora nell’università. La competizione produttivistica riduce gli spazi anche mentali per ragionare insieme sulla situazione presente.
L’enfasi dei vertici europei sull’accoglienza ai profughi ucraini in nome della loro comune appartenenza ai nostri “valori” si riflette sulla copertura giornalistica della guerra (si veda, ad esempio, il comunicato dell’Associazione dei Giornalisti Arabi e del Medio Oriente) e viene tradotta sul terreno, alle frontiere fra Ucraina e Polonia, nel respingimento di profughi provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente, con una prassi che contravviene alle disposizioni della commissaria europea agli Affari Interni. Queste pratiche sono in flagrante contraddizione con il diritto europeo e internazionale, ma non con le pratiche di governo dell’Unione. E sono in perfetta sintonia con la retorica ufficiale sui “valori”. Il Foglio ha tradotto crudamente, e con compiacimento, il riferimento del Presidente del Consiglio italiano alla «giungla della storia», in questi termini: «Il referendum ormai non è più tra la Russia e l’Occidente ma tra i selvaggi e civili».
Come studiose particolarmente sensibili ai disastri che questa retorica ha accompagnato e favorito fuori dal nostro “giardino di pace” e all’interno di esso (in particolare nelle politiche sull’immigrazione), esprimiamo viva preoccupazione per la crescente affermazione di un linguaggio che non lascia nessuno spazio alla libertà del pensiero. Mentre condanniamo la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e di risoluzione delle controversie internazionali e solidarizziamo con la popolazione civile ucraina la cui sovranità è stata aggredita in maniera ingiustificabile, riteniamo che sia anche giunto per le associazioni di studi come la nostra (e non solo), di aprirsi a un confronto per fare il punto sullo stato di salute della libertà di ricerca nel mondo accademico.
Proponiamo di unire le forze per organizzare giornate di studio, di riflessione, di discussione attiva per un confronto dentro e fuori le università che dia voce al pensiero critico, ora più che mai necessario, e invitiamo tutte le associazioni di studio che condividono le nostre preoccupazioni a contattarci all’e-mail segreteria@sesamoitalia.i
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Oltre la guerra: ripensare l’Europa e l’Occidente
Di fronte alla catastrofe umanitaria che si sta delineando in Ucraina, possibile prologo a una catastrofe di livello mondiale (nella consapevolezza che lo spettro di un disastroso conflitto nucleare non è più una lontana ipotesi, ma un qualcosa di terribilmente concreto), di fronte all’avventura neoimperialista e neonazionalista dello zar russo frutto anche delle scelte deleterie fatte dall’Occidente dopo il crollo dell’impero sovietico (scelte basate sulla ingenua quanto arrogante presunzione che si potesse andare verso un assetto mondiale unipolare, con in testa la bandiera a stelle e strisce), in queste ore drammatiche ci possono tornare utili le riflessioni, le analisi, di un grande intellettuale scomparso proprio un anno fa, Franco Cassano, a partire dal suo saggio più importante: Il pensiero meridiano. Cassano ci invitava a riscoprire le radici mediterranee dell’Europa e lo faceva rifacendosi alle idee di Albert Camus e Pierpaolo Pasolini. Lo faceva invitando a recuperare «il cuore greco della nostra civiltà, quell’amore classico per il cosmo che è stato infranto dalla tradizione ebraico-cristiana», nella consapevolezza che «la natura umana è parte di una natura più grande». Ma soprattutto nella convinzione che nei secoli l’Europa ha volto lo sguardo sempre più a Nord, come mi disse in una intervista che gli feci proprio dopo l’uscita de Il pensiero meridiano. A partire dalla scoperta dell’America, portatrice di uno dei grandi genocidi della storia, e imprinting di quegli Stati Uniti, nati alcuni secoli dopo, dove schiavismo, colonialismo e imperialismo si sono affermati con le conseguenza che abbiamo visto, a fronte, paradossalmente, di un Paese dove si sono sviluppati, ma forse proprio come contrappeso, grandi movimenti novecenteschi, da quello operaio degli IWW alle contestazioni studentesche prologo del ’68 mondiale.
Dunque Franco Cassano venticinque anni fa ‒ il testo è del 1997 ‒ riteneva fondamentale ripensare l’Occidente, soprattutto valorizzare un’Europa mediterranea, mettendo da parte il delirio di onnipotenza e qualunque mira egemonica, ponendo al centro il rapporto con la natura, mettendo da parte «il protagonismo dello spirito, il suo autonomizzarsi e contrapporsi alla natura» (parole profetiche visto ciò che si è palesato negli anni successivi e si sta palesando oggi con il rilancio proprio in questi mesi ‒ e in queste ore ‒ di politiche energetiche disastrose), evidenziando l’inconsistenza e la falsità della decantata “transizione ecologica”.
E anche Slavoj Zizek, altro pensatore controcorrente, ha sottolineato la necessità di guardare al Sud per sottrarsi alle dinamiche che ci hanno condotto a questa situazione. Cioè a dinamiche che abbiamo visto ripetersi in questi ultimi trent’anni per cui si foraggia, si fanno affari con il satrapo di turno ‒ si chiami Saddam, Gheddafi o Putin ‒ e poi lo si scarica nel gioco delle alleanze mutevoli, del business e in ottemperanza alla logica del profitto (con la differenza, questa volta, che di fronte c’è un imperialismo agguerrito e con una micidiale arsenale nucleare). A dinamiche che hanno portato non al logico scioglimento della Nato, dato che la guerra fredda era terminata con la scomparsa dello scenario formatosi dopo il secondo conflitto mondiale, ma al suo rafforzamento e alla sua miope e suicida estensione, con la graduale annessione di buona parte dell’Est europeo, ignorando che Paesi da poco tempo fuori dal dominio totalitario, dopo secoli di oppressione (prima zarista poi del cosiddetto “socialismo reale”), inevitabilmente avrebbero visto affermarsi un nazionalismo e un revanscismo che si è dispiegato sotto i nostri occhi, con gli esempi polacchi e ungheresi, dove si sono insediati esecutivi reazionari, omofobi e razzisti. Un nazionalismo ampiamente presente anche in Ucraina che in questi giorni si è evidenziato di fronte alla criminale aggressione putiniana.
Paesi che respingono alle loro frontiere le migliaia di migranti anche loro in fuga da guerre e oppressione, spesso conseguenza delle politiche delle varie potenze, ma che hanno il “torto” di avere la pelle scura, per cui proprio in queste ore assistiamo a un’umanità in fuga dalle bombe russe, ma che trova accoglienza perché ha la pelle bianca, non è afgana, curda o pakistana.
La guerra ha portato le piazze di tutto il mondo a riempirsi. Manifestazioni importanti, soprattutto quelle che coraggiosamente si sono verificate nella Russia sotto il giogo del regime putiniano, ma che non ci possono far dimenticare come quasi vent’anni fa un’altra guerra criminale, basata sulla menzogna, vide scendere nelle piazze quella che fu definita “la seconda potenzia mondiale”, la quale però dovette subire una sconfitta pesantissima di cui portiamo ancora le conseguenze. Ma del resto seppur con la sensazione di impotenza di fronte al gioco perverso del “trono di spade” a cui assistiamo, non abbiamo altra scelta se non quella di premere, gridare affinché una politica non di potenza, ma appunto che si rifaccia a quella tradizione di pensiero di cui parlava Cassano, possa farsi strada tra nazionalismi, imperialismi e corsa suicida all’armamento.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>
I sindacati e il futuro di Stellantis: aspettando Godot
10-03-2022 – di: Adriano Serafino
Aspettando Godot, grande opera teatrale di Samuel Beckett, è diventato un modo di dire per indicare una situazione in cui si continua ad attendere, passivamente ma fiduciosi, un qualcosa d’importante che appare imminente. Stellantis aspetta il mercato…, i sindacati aspettano Stellantis… Si aspetta Godot per il futuro di Mirafiori e per i progetti di Stellantis in Italia? Pensiamo di sì.
L’amministratore delegato della società Carlos Tavares, in un’intervista a Federico Fubini sul Corriere della Sera del 18 gennaio 2022, ha, tra l’altro, dichiarato: «Bisognerebbe che gli incentivi [per l’auto elettrica, ndr] fossero mantenuti almeno fino al 2025. Ma non credo che i governi potranno continuare a sovvenzionare la vendita di veicoli elettrici ai livelli attuali, non è sostenibile dal punto di vista del bilancio. Quindi torniamo al rischio sociale. È la brutalità del cambiamento che lo crea. Se gli Stati riescono ad accompagnare questa transizione con delle sovvenzioni per cinque anni, forse ce la caveremo. Altrimenti si fanno prendere più rischi sociali all’insieme della cittadinanza. […] Chiudere significa mettere un lucchetto alla porta e mandare tutti a casa. Non l’abbiamo fatto. E se posso evitarlo, lo eviterò. Di solito mantengo le mie promesse, ma dobbiamo anche restare competitivi. Il futuro dei nostri siti dipenderà anche dai vincoli politici sulla decarbonizzazione in Europa e dalle sue conseguenze sul mercato dell’auto. […] Un anno fa, ho notato che in Italia il costo di produzione di un’auto era significativamente più alto, a volte doppio, rispetto alle fabbriche di altri Paesi europei, nonostante un costo del lavoro più basso. Questo ha a che fare con l’organizzazione della produzione, che va migliorata». Poi, all’inizio di marzo, ad Amsterdam, ha illustrato gli obiettivi del piano “Dare Forward 2030” (“Osiamo verso il 2030”).
Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha espresso il suo commento e ciò che intende fare su La Repubblica in un’intervista a Diego Longhin dal titolo “Il futuro di Mirafiori e le strategie di Torino” in cui spiega che il suo obiettivo è incontrare Carlos Tavares per discutere delle prospettive locali all’interno dei paletti del piano, cercando di capire quali possano essere le leve dello sviluppo. Il quotidiano della Cisl Conquiste del Lavoro ha commentato riprendendo la dichiarazione congiunta del segretario generale della Fim-Cisl Roberto Bertaglia e del responsabile nazionale Settore automotive Ferdinando Uliano: «Un piano strategico e ambizioso, dal titolo Dare Forward 2030, che punta ad ottenere ricavi di oltre 300 miliardi di euro e produrre cento nuovi modelli entro la fine del decennio, tra i quali il primo suv Jeep 100% elettrico in arrivo a inizio 2023». Da Zaandam, vicino Amsterdam, il ceo Carlos Tavares non dà indicazioni precise sul futuro delle fabbriche italiane e non arriva neanche la notizia della firma dell’accordo per la Gigafactory di Termoli, per il quale ci vorranno ancora alcune settimane. Tavares assicura comunque che l’Italia è una delle colonne del Gruppo e che si sta investendo per rilanciare Alfa e Lancia e per elettrificare la Fiat. «È stato indubbiamente utile conoscere le strategie complessive del Gruppo Stellantis, la sua visione e le scelte di prospettiva di un settore in forte cambiamento» affermano Bertaglia e Uliano, limitandosi a sottolineare che è indispensabile comprendere quali siano le scelte di investimento e di prospettiva che riguardano le realtà italiane di Stellantis. I sindacati – come gli amministratori torinesi e piemontesi – sono, da tempo, in attesa di risposte “per capire” le reali intenzioni di Tavares (come già anni addietro con Sergio Marchionne). Attendono qualcosa di nuovo come i due vecchi signori di Aspettando Godot. Eppure le risposte per comprendere quanto può avvenire a Mirafiori e negli stabilimenti italiani Tavares le ha date, e per completarle attende anche lui: non Godot ma il mercato. Da Amsterdam, fa inoltre sapere che non esiste alcun interesse e utilità perché lo Stato italiano entri nell’azionariato di Stellantis.
Il sindacato, insomma, non se la sente, non ha maturato la capacità per aggiornare la sua strategia, e neppure si interroga se per avere qualche chance di successo debba essere unitaria; passivamente si adegua che l’occupazione decresca in modo “morbido” con montagne di ore di cassa integrazione e di contratti di solidarietà finalizzati all’uscita anticipata dal lavoro. Pur cosciente che il motore elettrico comporterà una riduzione di mano d’opera, non pensa neppure di adeguare la contrattazione includendo tra i punti prioritari la riduzione dell’orario, con finalità e modalità di finanziamento diverse da quanto fatto nel secolo scorso.
Infine perché lasciare nell’oblio – a proposito dell’aspettare il mercato – quanto disse Sergio Marchionne, nel 2016, agli studenti della Luiss? Nella grande aula dell’Università, davanti a studenti dei ventinove paesi dell’Unione europea, Sergio Marchionne – proprio lui – sciorinò consigli, suggestioni e concetti su cui vale la pena di riflettere anziché confidare nelle parole e nelle promesse del nuovo amministratore delegato di Stellantis: «Non possiamo demandare al funzionamento dei mercati la creazione di una società equa: i mercati non hanno coscienza, non hanno morale. […] Se li lasciamo agire come meccanismo operativo della società, tratteranno la vita umana come una merce. […] C’è un limite oltre il quale il profitto diventa avidità» (Fabio Martini, I mercati sono senza morale. Serve agire con coscienza, La Stampa 28 agosto 2016).
Perché i sindacati non si danno una mossa prendendo spunto da quelle affermazioni? I mercati si formano e s’indirizzano con gli investimenti che un Consiglio di Amministrazione decide. In questi anni una buona fetta dei profitti hanno premiato gli azionisti con consistenti cedole, in particolare per John Elkan & soci. È una grave anomalia quella che porta i sindacalisti a “sognare” un ipotetico posto nel Consiglio di Amministrazione, per rappresentare i lavoratori, e nel contempo a “dimenticare” di chiedere – in questa fase difficile della transizione ecologica e digitale – che sia posto uno stop per alcuni anni alla distribuzione di quote dei profitti agli azionisti al fine di indirizzare più risorse agli investimenti per la transizione. A questa “dimenticanza” fa seguito l’insistenza di richiesta di sostegno finanziario al “pozzo di San Patrizio” dello Stato. Le due cose stridono. È forse retrò dire questo? Cose dell’altro secolo?
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
La guerra in Ucraina e il nuovo scontro di civiltà

All’alba del nono giorno di guerra l’attacco delle truppe russe alla centrale nucleare Zaporizhzhia rende meglio di qualunque altro dettaglio quale sia la posta della partita globale, biopolitica prima che geopolitica, che si sta giocando in Ucraina. E il peggio deve ancora venire, ha comunicato Macron cui Putin ha fatto presente che non intende fermarsi finché non avrà conquistato l’intero paese. Le regioni russe dell’est e del sud con gli accessi al mare sono ormai in mano ai russi, a Mariupol mezzo milione di abitanti sono intrappolati senza acqua e senza cibo, a nord-ovest Leopoli è piena di profughi in fuga, più donne e bambini che uomini perché gli uomini restano a combattere una battaglia di resistenza già persa. L’esile negoziato in corso a Brest ha deciso l’apertura di corridoi umanitari per favorire l’esodo dei civili, mentre la colonna di 60 kilometri di carri russi continua la sua lenta ma inesorabile avanzata su Kiev lungo il corso del Dnepr che in futuro potrebbe dividere l’Ucraina fra un est russo e un ovest occidentale, com’era un tempo la Germania: le stesse cose ritornano sempre, nella storia, come il rimosso nell’inconscio. Dev’essere per questo che tutti definiscono questa in Ucraina “la prima guerra nel cuore dell’Europa dopo più di settant’anni”, dimenticando clamorosamente che in Europa la guerra era già tornata negli anni Novanta, in quella ex Jugoslavia che ha anticipato e prefigurato tutte le guerre successive a base etnico-nazionalista sparse per il mondo. Forse che la Jugoslavia non era il cuore ma la periferia dell’Europa? O non sarà piuttosto che nell’immaginario europeo, il cuore dell’Europa resta sempre lì, al confine fra l’ex impero sovietico e l’Occidente democratico? Lì, dove secondo gli stessi che nell’89 decretavano “la fine della storia” oggi la storia riprenderebbe in grande, quasi che in mezzo non ci fosse stato niente. Lì, dove si sono convocati tutti i fantasmi che fino a ieri l’altro vagavano per l’est e per l’ovest, e che ora muovono questa terribile resa dei conti di un trentennio cominciato male e finito peggio. Che è la vera posta in gioco, reale e simbolica, della tragedia che si sta consumando.

Hanno suscitato indignazione e scandalo i due discorsi del 21 e del 24 febbraio con cui Putin ha annunciato prima il riconoscimento ufficiale delle repubbliche separatiste del Donbass e poi la sua “operazione militare speciale”, come l’ha chiamata lui, in Ucraina. Ne consiglierei tuttavia la lettura integrale (il testo è facilmente reperibile in rete), ammesso che sia ancora lecito cercare di capire perché accade quello che accade senza essere tacciati di connivenza con il nemico. Liquidati dai più come una litania del risentimento, o come il delirio paranoico da sindrome di accerchiamento di un uomo solo al comando provato dalla fobia del Covid, i due discorsi inanellano alcuni dati di fatto incontrovertibili sull’estensione a est della Nato, sulle guerre di aggressione perpetrate dall’Occidente dagli anni novanta in poi (Kosovo, Iraq, Siria, Libia), e, più in generale, sullo “stato di euforia da superiorità assoluta, una sorta di assolutismo di tipo moderno, per di più sullo sfondo di un basso livello di cultura generale” che si è impossessato del campo dei vincitori della Guerra fredda. Ma al di là di questo merito, nonché della ricostruzione delle cause di lungo periodo della rinascita dei nazionalismi, a Est dopo la fine dell’Urss, ciò che colpisce nelle parole di Putin è la rivendicazione della dimensione storica come sfondo ineludibile del discorso politico. Precisamente lo sfondo che manca al discorso politico occidentale, che di spessore storico sarebbe supposto essere il più dotato. E che invece risponde all’aggressione di Putin usando – mirabile sintesi di un cinquantennio di ideologia neoliberale – solo il linguaggio dell’economia e della sicurezza: sanzioni e riarmo, nell’oblio – perfino teorizzato, come nel discorso alle camere di Mario Draghi – del passato che ha costruito, mattone dopo mattone, il presente.

Sia chiaro: lo sfondo e l’uso della storia non giustificano in alcun modo la mossa di Putin. L’invasione di uno Stato sovrano e confinante viola le basi del diritto internazionale, resuscita, a proposito di storia lunga, tutti i mostri del passato europeo, e si configura per di più, nelle stesse motivazioni che Putin ne dà, come una sorta di preemptive war, una guerra preventiva contro il pericolo eventuale di un’aggressione alla Russia da parte della Nato (i nemici assoluti sono spesso segretamente gemelli, e Putin evidentemente ha imparato qualcosa da George W. Bush). Nessuna ragione di lungo periodo esenta di un grammo di responsabilità la decisione con cui il presidente russo ha portato il mondo sull’orlo del precipizio. Ma pare assai improbabile che dal precipizio le democrazie occidentali possano uscire senza aprire al proprio interno tre linee di ripensamento autocritico di un passato prossimo che invece tendono solo a rimuovere o a riconfermare.

La prima linea riguarda l’atroce sequenza di guerre con cui l’Occidente ha insanguinato l’epoca di pace che aveva annunciato alla fine della Guerra fredda, e che rischiano di costituire i precedenti formali, non solo le concause politiche, dello scenario che si va prefigurando in Europa. Dovrebbe balzare agli occhi l’analogia agghiacciante fra le motivazioni addotte da Putin a sostegno della minoranza russa in Ucraina e quelle che mossero il cosiddetto intervento umanitario della Nato a sostegno della minoranza kosovara in Serbia, con relativo bombardamento di Belgrado: e invece non un cenno se ne sente in specie nel Pd, erede del partito che fu il principale regista italiano di quella guerra, oggi abitato da una classe dirigente che sembra del tutto ignara della drammaticità di quella stagione e del tutto conforme alla narrativa trionfale del dopo-’89. Dovrebbe risuonare come un monito sullo stato delle democrazie occidentali la madre di tutte le fake news e di tutte le post-truth politics, ovvero la gigantesca menzogna sulle presunte armi di distruzione di massa possedute da Saddam Hussein che giustificò la “guerra preventiva” in Iraq. Soprattutto, dovrebbe portare un grammo di senno, questo sì preventivo, sullo scenario europeo prossimo venturo la scia di guerre civili, regimi instabili ed esodi migratori biblici lasciata dietro di sé dall’intera sequenza delle guerre post-89, tutte caratterizzate dall’intreccio micidiale di rivendicazioni nazional-sovraniste e rivendicazioni etnico-regionali che si ripropone oggi in Ucraina e rischia di riproporsi in un teatro europeo più vasto di quello ucraino. E invece è proprio nella ripetizione nevrotica di quella dinamica che ci stiamo infilando, con il corredo sinistro di un soccorso armato alla resistenza ucraina fatto di contractors, appalti, privatizzazione dell’uso della forza – un film, anche questo, già visto in Iraq e in Siria, con le conseguenze che sappiamo.

La seconda linea di riflessione autocritica riguarda lo stato delle democrazie occidentali e quello connesso della costruzione europea. Oggi siamo tutti dalla parte dell’Ucraina, vittima di un’aggressione inammissibile, e da questa parte bisogna restare finché i carri armati russi resteranno in campo. Ma nella retorica monotonale occidentale l’Ucraina è diventata in pochi attimi la trincea della difesa della democrazia tout court, anzi, per dirla con le parole di Joe Biden nel suo discorso sullo stato dell’Unione, la trincea del conflitto fondamentale del nostro tempo, che sarebbe quello fra democrazia e autocrazia. Le élite democratiche americane sono impegnate da tempo a costruire questo frame narrativo, opposto e speculare all’attacco alla liberaldemocrazia occidentale portato avanti dalla concezione putiniana della cosiddetta “democrazia sovrana”. E se nella politica interna americana questo frame è servito a sconfiggere Trump, in politica estera è destinato a prendere il posto di quello sullo “scontro di civiltà” fra Occidente e Islam che ha tenuto banco per tutto il ventennio della war on terror successivo all’11 settembre. Ma dopo Trump, gli americani non possono non sapere che la linea di confine fra democrazie e autocrazie è diventata molto esile, e può essere scavalcata dagli autocrati che crescono all’interno delle democrazie occidentali, non soltanto al di fuori di esse. E noi europei non possiamo non sapere che le tentazioni autocratiche e sovran-populiste sono cresciute, soprattutto ma non solo nei paesi ex-sovietici dell’est, parallelamente ai processi di crisi e de-democratizzazione dei paesi dell’ovest, e sovente per reazione alla delusione di un allargamento a est dell’Unione rivelatosi più un’annessione alla religione del mercato che un’integrazione del mosaico di culture e tradizioni del vecchio continente. Anche da questa parte dell’oceano, il pericolo autocratico non viene solo dall’esterno, e la democrazia non può essere impugnata come una bandiera senza macchia e senza peccato.

Questo nodo lega il trentennio che abbiamo alle spalle al presente e al futuro dell’Unione europea e della sua collocazione nello scacchiere globale. Il rilancio dell’atlantismo da parte di Joe Biden appariva molto ambivalente già all’indomani della sua elezione: mentre riavvicinava le due sponde dell’Atlantico che Trump aveva allontanato, innalzava un nuovo muro fra l’Europa e le autocrazie orientali, chiamando la Ue a posizionarsi nettamente contro di esse. Già allora le voci più consapevoli spinsero infatti per un’Unione atlantista ma aperta verso Est e capace di porsi come ponte fra gli Stati uniti, la Russia e la Cina. Complice la fine del cancellierato di Angela Merkel, nonché verosimilmente l’insediamento del governo Draghi in Italia, le cose hanno preso purtroppo un’altra piega. E oggi è più che inquietante il coro mainstream di soddisfazione che si leva per un compattamento europeo che fa propria la parola d’ordine americana del nuovo scontro di civiltà fra Occidente e Oriente, e avviene tutto sotto l’insegna della Nato, di sanzioni durissime che colpiranno Putin ma affosseranno la transizione energetica europea, di una politica di pura potenza, di un riarmo di cui la Germania si fa protagonista e che travolge persino la neutralità storica di paesi come la Finlandia.
Se si rafforza in questo modo, dopo aver clamorosamente mancato tutte le possibilità preventive di disinnescare politicamente la miccia che Putin stava accendendo, l’Unione europea finirà col fare le spese del ridisegno dell’ordine globale che si sta giocando nella guerra fra l’imperialismo russo e il nazionalismo ucraino. Se in Ucraina non cessa il fuoco e l’Europa non inverte la rotta imboccando la strada della smilitarizzazione, il conflitto si estenderà in modo imprevedibile e i tempi si faranno durissimi per la specie umana. Se le democrazie si compatteranno al loro interno sulla base dell’ennesima proclamazione dello stato d’emergenza, come già sta avvenendo in Italia, la credibilità della democrazia subirà un ennesimo e fatale colpo. Come sempre e mai come oggi, per incidere sullo scacchiere geopolitico il pacifismo deve alimentarsi di un conflitto politico aspro dentro casa, in primo luogo contro la militarizzazione del dibattito pubblico.

L’articolo è stato pubblicato sul sito web del Centro per la riforma dello Stato
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

NUOVI ARTICOLI :
Vita reale, bollette, inflazione
14-02-2022 – di: Luigi Pandolfi
1.
Mentre il Governo e i media mainstream continuano a celebrare – invero con minore enfasi – il recupero della nostra economia (il “rimbalzo” del 6,5% nel 2021 è stato di quasi due punti e mezzo sotto il tonfo dell’anno precedente e adesso l’Ue rivede al ribasso la crescita nel 2022, intorno al 4%), la vita reale, quella delle persone in carne e ossa, famiglie, lavoratori, subisce pesantemente gli effetti nefasti della tendenza rialzista dei prezzi. È tornata l’inflazione, cresce il costo delle utenze (a gennaio aumenti del 40% per il gas e del 50% per la luce). Ma non è la conseguenza della crescita di salari, stipendi e pensioni e non c’entra nemmeno la politica monetaria espansiva della BCE.
In Italia i salari sono pressoché fermi da decenni. Anzi, sono addirittura diminuiti negli ultimi trent’anni. E non c’è più un meccanismo di adeguamento automatico degli stessi al costo della vita (la “scala mobile” fu soppressa nel 1992). Uno studio recente di OpenPolis condotto sulla base di dati OCSE ha dimostrato che nel nostro Paese il salario medio annuale è sceso del 2,9% dal 1990 a oggi. Unico caso in tutta l’Unione europea. Impietoso il confronto con altri Paesi a noi vicini, non solo geograficamente: in Germania e in Francia, ad esempio, le retribuzioni medie sono aumentate rispettivamente del 33,7% e del 31,1%, pur partendo da livelli già più alti dei nostri. Anche la Grecia ha fatto registrare un incremento del 30%. Come la Spagna, con il suo +6,2%, nonostante le similitudini con il nostro mercato del lavoro. Dunque?
Stando ai fondamentali, si può dire che questi rincari sono figli della ripresa economica. Il “rimbalzo” dell’economia sta portando con sé uno squilibrio tra domanda e offerta dei materiali di base della produzione. L’offerta di questi beni, in sostanza, non regge i ritmi della ripartenza: i cosiddetti “colli di bottiglia” che si sono venuti a creare nelle catene globali di approvvigionamento di materie prime, beni energetici e semilavorati a causa della pandemia. Inflazione da costi. Come se non bastasse, poi, ci si è messa anche la crisi ucraina. Nelle settimane scorse la Russia ha tagliato del 43% le forniture di gas all’Italia. E Gazprom, come è noto, rappresenta il principale approvvigionatore di metano del nostro Paese. L’anno scorso il 41% del gas che abbiamo consumato è venuto da lì. Una “tempesta perfetta” si potrebbe dire. Non a caso Draghi nei giorni scorsi ha voluto sentire Putin. Hanno parlato della tensione al confine con l’ex Repubblica sovietica, ma soprattutto, come ha fatto trapelare l’agenzia Tass, di metri cubi di metano.
2.
Sarebbe tuttavia semplicistico ridurre la questione a un problema di geopolitica e di approvvigionamenti. Al tempo del “finanzcapitalismo” (efficace espressione del compianto Luciano Gallino) la macroeconomia non è più intellegibile senza fare un giro per i mercati finanziari. La storia degli ultimi quarant’anni, almeno, dimostra che mercati finanziari e mercati reali di beni e servizi, oltre che la stessa produzione di quest’ultimi, non costituiscono compartimenti separati della sfera economica. Non solo.
Dovrebbe essere chiaro ormai a tutti che è proprio la finanza, con le sue dinamiche speculative e le sue aspettative di breve e brevissimo periodo, a guidare i processi economici reali. Nessuna esigenza reale, che sia sociale o ambientale, può costituire un freno o un deterrente per i grandi player del gioco speculativo globale. Si scommette sul petrolio, sul grano e i principali beni alimentari, sulle catastrofi naturali, sul clima, sulla morte (il caso estremo dei “bond della morte” lanciati dalla Deutsche Bank nel 2012) e perfino sul fallimento altrui. Pecunia non olet. Infatti, non è un caso che da un po’ di tempo a questa parte sia finito nel vortice della speculazione anche il diritto a inquinare. Parliamo dei cosiddetti “crediti di carbonio”, che in Europa rimandano all’EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme). Sei un’impresa che produce emissioni in atmosfera? Il sistema ti assegna una sorta di budget di emissioni sotto forma di “quote”. C’è però chi alla fine dell’anno le sue quote se l’è consumate ed è andato anche oltre e chi, invece, ne ha risparmiate alcune mantenendosi sotto soglia. In questo modo, da un lato ci sarà chi potrà vendere le quote risparmiate, dall’altro chi sarà costretto a comprare sul mercato quelle che gli mancano. Il mercato della CO2. Cosa sta succedendo adesso? Con la fine dei lockdown c’è un rimbalzo della produzione. Più produzione, però, comporta anche più emissioni, che a loro volta richiedono un supplemento di permessi a inquinare. Siccome il numero di “quote” è rimasto invariato a fronte di una domanda che è cresciuta, si ha un aumento del prezzo delle stesse, che viene scaricato sui consumatori. Gli economisti spiegherebbero questo fenomeno con il concetto di “utilità marginale”. Per altro verso, siamo di fronte al grande paradosso della “transizione ecologica” affidata alla logica del mercato.
Poteva sfuggire questo business alla finanza speculativa? Impensabile. Infatti il mercato di strumenti finanziari “a base” di CO2 negli ultimi anni ha fatto passi da gigante e con la pandemia è letteralmente esploso. Ma l’equilibrio nel sistema delle emissioni non c’entra più niente: quello che conta è solo l’andamento dei prezzi di questi prodotti. Chi scommette sul prezzo delle “quote di emissione” pensa al suo guadagno nel minor tempo possibile, non certo al benessere dell’umanità. E se il guadagno può derivare da un aggravamento della condizione climatica del pianeta o da qualsiasi altro evento avverso, come la pandemia, che ben venga questo aggravamento. Transizione ecologica o ecological trading?

3.
Più indietro dicevamo che mercati finanziari e mercati di beni e servizi (+ produzione) non sono indipendenti gli uni dagli altri. A tal punto che spesso è il gioco delle scommesse che determina il prezzo di beni reali. Vale per il petrolio, per gli alimenti, per il gas e anche per i “diritti di emissione” che le industrie devono reperire sul mercato per stare entro i limiti imposti dal sistema. Non solo chiusure, “colli di bottiglia” e geopolitica, quindi. La stima è che, per quanto riguarda il nostro Paese, l’80 per cento del rincaro delle bollette è da riferire all’aumento del prezzo del gas naturale, mentre il 20 per cento è da attribuire all’aumento dei prezzi dei permessi di emissione. Nondimeno, questi aumenti dei prezzi solo per una parte sono riferibili a dinamiche reali. Il resto è figlio della speculazione finanziaria. Un circolo vizioso che si autoalimenta: squilibri di mercato e speculazione finanziaria che portano in alto il prezzo delle materie prime e delle quote di CO2, con ricadute pesanti sui costi di produzione, che, a loro volta, vengono scaricati sul consumatore finale, dal carrello della spesa alle utenze di luce e gas.
Caro bollette e carovita, quindi. Il rischio adesso è che di questa inflazione, con annesso costo delle utenze, siano solo i ceti popolari e le piccole attività a pagare dazio. Tutti quelli che ancora portano i segni della crisi precedente e che nella pandemia ci sono entrati con le ossa rotte. La “ripresa” bacia gli abbienti, non migliora le condizioni materiali di vita di chi sta sotto. Siamo sempre lì: è una questione di distribuzione del reddito tra salari, profitti e rendita finanziaria. Una distribuzione che negli ultimi decenni nel nostro Paese ha accentuato vistosamente i suoi tratti di iniquità. Siamo un Paese fortemente diseguale che tende ormai da molti anni alla polarizzazione dei redditi. Un dato di sistema, strutturale. Negli ultimi due anni, secondo le stime di Oxfam, altre tredici persone sono entrate nel club dei miliardari, mentre i poveri sono aumentati di un milione e trecentomila unità. Ora i poveri assoluti sono di nuovo più di cinque milioni, il doppio di quindici anni fa. E l’inflazione non ha ancora fatto fino in fondo il suo “lavoro”. Senza misure di compensazione sarà inevitabile che l’aumento dei prezzi faccia contemporaneamente aumentare la platea degli indigenti. Misure per il caro bollette e bonus emergenziali servono ma non bastano. Ci vuole un’opera di redistribuzione della ricchezza, dall’alto verso il basso. Le leve sono il fisco, l’introduzione di un salario minimo, nuove forme di indicizzazione delle retribuzioni. Più in generale è il problema di come si vuole uscire da questa crisi. Non c’è solo il lavoro povero di chi un lavoro stabile ce l’ha. Troppo esteso è anche il bacino del lavoro precario, intermittente, iper-flessibile, e di chi un lavoro non ce l’ha proprio. Del milione di posti di lavoro persi a causa del Covid se ne sono recuperati all’incirca cinquecentomila grazie al “rimbalzo” dell’economia. Ma la gran parte di questi contratti sono a tempo determinato. Lavoro instabile e sottopagato, finte partite Iva. Anche per questo c’è da scongiurare che l’inflazione diventi il pretesto per una nuova stagione di attacco al welfare e ai diritti dei lavoratori, come tante volte è accaduto nel passato.
Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi del Giorno del Ricordo
di: Tomaso Montanari
Una nota di metodo preliminare che temo ormai non sia ovvia o superflua come dovrebbe essere: l’università non si schiera politicamente. Ma l’antifascismo non è una posizione politica, bensì una premessa costituzionale e istituzionale non negoziabile e indispensabile. La nostra università, come tutte le altre università, come tutte le università di una Repubblica fondata sull’antifascismo, è un’istituzione, è una comunità dichiaratamente antifascista. Non potrebbe essere altrimenti. Se tutti siamo ben consapevoli che l’uso politico della memoria ha una storia non meno lunga della storia di una civiltà, siamo anche ben consapevoli che oggi in Italia il revanscismo fascista goda di appoggi, mezzi, organizzazioni e di un consenso fino a qualche anno fa impensabile. Siamo anche consapevoli che queste forze strumentalizzano con crescente successo sia le drammatiche vicende del confine orientale, con la loro scia di sangue, sia le celebrazioni pubbliche del Giorno del Ricordo.
È annunciato per domani a Firenze un cospicuo raduno di forze neofasciste e neonaziste e uno dei relatori di questo seminario, Eric Gobetti, avrebbe dovuto tenere nella stessa giornata una lezione in un liceo di Verona, ma gli è stato proposto che la lezione si trasformasse in un contraddittorio con un giornalista. Chi ha letto il libro di Paolo Berizzi È gradita la camicia nera sa quale sia la situazione di Verona in questo momento. Sottolineo, a rimarcare la particolare situazione dell’Italia, che Paolo Berizzi è l’unico giornalista europeo che vive sotto scorta per le minacce di matrice fascista.
A Siena, da settimane, la sezione di un partito che si trova al governo della città, intitolata al segretario di redazione della Difesa della razza raccoglie per strada firme per le mie dimissioni e oggi un’interrogazione parlamentare di un partito di governo ha chiesto alla ministra dell’Università, «se sia legittimo che un rettore possa assumere liberamente iniziative di critica esplicita di una legge dello Stato». Non so su quale pianeta siamo, probabilmente su Marte come Corrado Guzzanti suggeriva qualche tempo fa.
L’autonomia della scuola e dell’università dal potere politico è dunque pesantemente messa in discussione ed è un valore, una norma della Costituzione a proteggerla. Di fronte a tutto questo credo fermamente che l’unica risposta possibile sia fare ancora meglio e con ancor più decisione il nostro lavoro di studiosi e di professori.
Da qui l’idea di un seminario invitando studiosi che da giuristi e storici possano illuminare il contesto, i moventi profondi, la lunga preparazione e le implicazioni dell’istituzione del Giorno del Ricordo con la legge 92 del 30 marzo 2004, perché è impossibile studiare tutto questo senza prendere in considerazione almeno la fase finale di quella che Filippo Focardi ha definito «la guerra della memoria», memoria che – come sottolinea Alberto Cavaglion – «andrebbe decontaminata».
In particolare è assai interessante studiare, oltre agli argomenti accolti nel dibattito parlamentare che precede l’approvazione della legge, il discorso pubblico dei primissimi anni Duemila quando perfino la retorica del presidente della Repubblica, allora Carlo Azeglio Ciampi, mosso dal sincero desiderio di attualizzare la memoria della Resistenza, si trovò di fatto a dover tenere conto di istanze che incrinavano l’egemonia culturale antifascista e che erano state da poco legittimate dall’arrivo dei postfascisti al governo del Paese, in un intreccio strettissimo tra vicende politiche e costruzione della memoria politica. Era un processo che affondava le radici almeno negli anni Ottanta e che, come sempre, aveva più a che fare con l’assetto degli equilibri politici del presente che non con il lavoro degli storici. Se riprendiamo i dibattiti di quegli anni, pare di poter dire che assai più di quello del ceto politico fosse lungimirante lo sguardo di alcuni intellettuali liberi da posizioni di schieramento. Penso ad esempio ad Antonio Tabucchi, capace di prevedere con estrema lucidità ciò che le prese di posizione dei vertici della Repubblica avrebbero innescato negli anni successivi. Anni che purtroppo Tabucchi non poté vedere.
E non è necessario chiarire solo gli antefatti della creazione del Giorno del Ricordo, ma anche indagare ciò che è avvenuto negli anni successivi in una catena di decisioni che tendono a saldare, con un respiro sempre più corto, la politica della memoria alle necessità politiche del presente. È chiaro, per fare un esempio, che anche la legge n. 115 del 2016, che punisce penalmente le affermazioni negazioniste sull’Olocausto, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, sia un sintomo preoccupante perché risolve con una legge ciò che si dovrebbe risolvere a scuola, come notò tra gli altri Carlo Ginzburg, fermo oppositore della legge, perché è un segno di evidente debolezza che tradisce la fine di una egemonia culturale e perché, ce ne rendiamo conto oggi, prepara gli strumenti perché una nuova egemonia farà rispettare una ortodossia di segno contrario.
È il testo dell’introduzione, svolta dal rettore Tomaso Montanari, al seminario pubblico “Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi del Giorno del Ricordo”, organizzato dall’Università per stranieri di Siena il 9 febbraio 2022, che può essere ascoltato per intero all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=P_oLgzgjiz4.